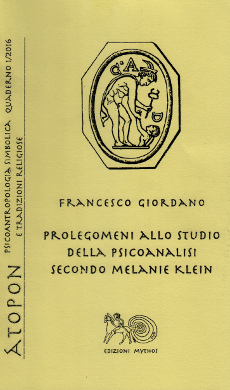Melanconia e Depressione: aspetti psichiatrici e socio-culturali
Il termine melanconia (melancolia o malinconia) ha designato, fino all’introduzione dei Manuali Statistico-Diagnostici dei disturbi mentali, a partire dal DSM III e III R (1980-1987), fino al IV (1994), tutta la gamma dei disturbi depressivi dell’umore, ad esclusione della depressione nevrotica e delle personalità abnormi depressive (Gozzetti et Al. 1999: 195).
Attualmente, il dualismo depressione nevrotica e psicosi melanconica è stato oramai abbandonato a favore di nozioni che comprendono un concetto di gradualità e/o di dimensionalità come spettro depressivo e continuum.
Ancora prima, la definizione di psicosi maniaco-depressiva, coniata da Kraepelin (1899), ebbe una grande diffusione nella trattatistica e rappresentò un contenitore nosografico omnicomprensivo di malattie dell’umore, che venne meno con la suddivisione tra disturbi monopolari e bipolari.
In genere, si è soliti distinguere in modo pragmatico la vera depressione o melanconia, che presenta una triade di segni caratteristici, rappresentati da tristezza vitale, ritmo circadiano alterato, con tipici disturbi del sonno, tematiche di autoaccusa, e la pseudodepressione, con il prototipo della depressione borderline, senza alterazioni circadiane, con disforia, a volte collera e tematiche di accusa nei riguardi dell’entourage terapeutico, gruppo terapeutico istituzionale, e mai autoaccuse (Kaplan et Al. 1997: 516-517).

Da un punto di vista descrittivo, si può considerare la melanconia come un disturbo del tono dell’umore, che si sviluppa entro una struttura psicotica, mentre la depressione rappresenta un fenomeno clinico caratterizzato da un abbassamento del tono dell’umore, che si sviluppa entro una struttura nevrotica (Gabbard 1995: 207), (Kaplan et Al. 1997: 52).
La depressione, nel suo significato più comune, è uno squilibrio del tono dell’umore.
L’umore opposto alla depressione è l’euforia. Lo squilibrio di tipo euforico, decisamente più raro di quello depressivo, viene definito mania; quando è meno spiccato viene definito ipomania.
Da un punto di vista nosografico, la depressione e la mania costituiscono le distimie o disturbi di tipo distimico (Kaplan et Al. 1997: 525).
L’umore depressivo viene considerato non normale, e quindi di competenza psichiatrica, quando sia l’intensità che la durata sono eccessive, o quando si presenta in circostanze che, secondo il senso comune, non lo giustificano. Quando la depressione supera certi limiti, assume caratteristiche psicotiche.
Da un punto di vista evolutivo, si può dire che il tono dell’umore, equilibrio tra depressione ed euforia, è il più fragile ed il più labile di tutti gli equilibri psichici. Non a caso nel neonato, la continua e labile alternanza tra gioia, soddisfazione, tristezza, infelicità e senso acuto di bisogno, costituisce un modo di essere molto semplice, ma anche la realtà esistenziale sulla quale si struttura tutta la vita psichica del soggetto.
Nell’adulto, a ben vedere, un assoluto equilibrio del tono dell’umore è raro. La normalità può essere definita una lieve euforia, ma facilmente una persona “normale” può andare incontro ad ore o giorni di lieve depressione. In generale, si può dire che un certo grado di euforia sia un aspetto costitutivo del desiderio di vivere, indispensabile per fare progetti, per considerare il futuro; d’altra parte, per poter fare progetti e considerare il futuro in termini realistici, è necessario un adeguato equilibrio del tono dell’umore.
Il tono dell’umore viene regolato da centri nervosi situati a livello della base del cervello, organizzati a formare un sistema complesso, il Sistema Limbico, le cui influenze sul funzionamento del Sistema Nervoso si fanno sentire attraverso numerose vie neuronali, i cui mediatori chimici sono alla base della moderna biochimica della depressione (Snyder 1989: 107). Il Sistema Limbico, infatti, è implicato in molte manifestazioni che contraddistinguono l’essere umano, in particolare le sensazioni, il comportamento, gli stati emotivi. Non svolge, tuttavia, le sue funzioni in modo isolato, ma interagisce con numerose vie ed aree corticali, non solo di tipo associativo e sensoriale, ma anche di tipo motorio, considerate d’importanza primaria anche nei processi cognitivi (Noback et Al. 1999: 317), (Kandel e Schwartz 2000: 653).
I suddetti centri risentono delle stimolazioni più varie. Esperienze di vita, ma anche fattori chimici, fisici e cinetici possono determinare uno squilibrio del tono dell’umore, più spesso verso la depressione, meno frequentemente verso l’euforia.
Nel corso della vita, fin dall’infanzia, l’individuo apprende a “tamponare”, a correggere i propri squilibri dell’umore, in particolare quelli che vanno verso aspetti di tipo depressivo. I meccanismi di equilibrio del tono dell’umore sono soprattutto meccanismi di tipo sociale, spesso a carattere collettivo e rituale, che vengono utilizzati per riattivare quel clima euforico che nella società contemporanea viene considerato “normale” (Minois 2005: 304).
Da un punto di vista fenomenologico, la difficoltà a riconoscere i due quadri patologici di malinconia e depressione sta nel fatto che essi non presentano vistose differenze tra di loro.
In entrambi si osserva la tendenza all’isolamento, vissuti d’inferiorità, autoaccuse, idee di rovina, profondo stato di prostrazione, revisione in chiave pessimistica del passato, mancanza di progettualità futura, negativismo generalizzato.
L’intensità del vissuto, d’altra parte, spesso non aiuta ad una differenziazione; anche le forme di depressione nevrotica, infatti, possono essere caratterizzate da un alto grado di sofferenza, fino a portare il soggetto verso uno stato d’invalidità generale, così come a tale livello di gravità può giungere anche un soggetto melanconico.
Non è, quindi, la sola osservazione del comportamento un utile e sufficiente strumento diagnostico; essa deve essere associata necessariamente ad un ascolto del paziente.
In questo può essere d’aiuto la clinica psicoanalitica, che pone al centro della sua attenzione proprio l’ascolto, ascolto di ciò che il soggetto dice, o meglio, e più in particolare, la “lettura del testo” che il paziente esprime con il suo racconto di sé, della sua storia. Attraverso un ascolto empatico, attento, non giudicante, è possibile andare oltre il visibile, a volte ingannevole ed equivoco, per giungere ad un possibile chiarimento delle differenti dinamiche in atto all’interno dei due diversi quadri psicopatologici (Lolli 2009: 26).
Per quanto riguarda il vissuto d’inferiorità, che così fortemente caratterizza sia la depressione che la malinconia, un’analisi del “punto d’enunciazione” e del suo contesto può chiarire meglio la prospettiva del tutto differente in cui si pone, a tale proposito, il soggetto depresso rispetto a quello melanconico.
Il soggetto depresso esprime il suo vissuto d’inferiorità e d’indegnità, il proprio non valere nulla sempre in rapporto all’Altro(*). Ciò di cui si rammarica è la perdita di valore per l’Altro. In questo caso il soggetto orienta la sua recriminazione verso l’Altro come causa del proprio dolore. Ci si trova di fronte ad una sofferenza delineabile secondo il paradigma della nevrosi, ove il pensiero, il vissuto di non valere si associano alla sensazione di non avere un posto nell’Altro, di non contare nulla per l’Altro, di essere fuori dal suo contenimento rassicurante. La dialettica con l’Altro, il lamento nei confronti dell’Altro sono ancora aperti; ciò ha grande importanza da un punto di vista diagnostico. In tal caso il soggetto rende più manifesto quanto è presente nella dinamica nevrotica: egli valuta se stesso solo in funzione dell’approvazione dell’Altro. La perdita dell’approvazione e del riconoscimento dell’Altro, per qualsiasi ragione, getta il soggetto in un vissuto d’inferiorità e di perdita di ogni valore, così tipico delle stato depressivo (Lolli 2009: 28).
La situazione che si osserva nella melanconia è del tutto differente. In tal caso, il soggetto che vive la sensazione di non valere nulla, si configura all’interno di un profondo ritiro in se stesso, in cui vi è la percezone lucida della radicalità di una condizione umana in cui è assente ogni forma di garanzia, di fondamento, di senso. Vi è la percezione dolorosa di essere al mondo con la propria fragilità, inermità, in cui poca importanza sembra avere l’individualità del singolo. Nel vissuto melanconico il senso di nullità si salda in modo inesorabile con la perdita di senso della condizione umana: ciò ha per l’individuo un effetto devastante. Qui l’Altro non è stato capace di guardare il soggetto con uno sguardo di accoglimento e di accettazione; qui si può dire che l’Altro è mancato fin da subito, non riconoscendo il soggetto nella sua individualità, nel suo valore unico ed insostituibile. Lo sguardo assente dell’Altro viene fatto proprio dal soggetto melanconico e con questo sguardo egli guarda se stesso ed il mondo: tutto perde significato, così come egli stesso non ha significato per l’Altro ( Lolli 2009: 30).

Nel depresso, la dinamica del desiderio che caratterizza il rapporto con l’Altro e le sue vicissitudini, la dialettica dell’essere desiderato e di desiderare, copre, maschera la strutturale inconsistenza e fragilità dell’essere umano. Il desiderio, in un certo qual modo, sembra così voler addolcire la durezza della condizione umana e la sua fondamentale assenza di senso. Assenza di senso che attanaglia il depresso nel momento in cui l’Altro sembra non voler rispondere più, non esserci più, quando il desiderio che sottende richieste di scambio e di riconoscimento da parte dell’Altro fallisce e, strappato come un velo, mostra la nudità della condizione umana e la sua fragilità priva di senso.
Nella malinconia non c’è questa possibilità di attenuare l’emergenza del vissuto profondo di nullità e d’inermità attraverso una dinamica di desiderio e di contenimento da parte dell’Altro. Qui il soggetto è solo di fronte a se stesso, drammaticamente solo di fronte al mondo; qui non c’è la rottura di un rapporto entro una dinamica di desiderio, bensì una condizione che è tale da sempre, immutata ed immutabile (Lolli 2009: 32).
Nella depressione, in ultimo, c’è ancora la possibilità di dialogo con l’Altro, un movimento dell’Altro, un riconoscimento da parte sua, una sua apertura verso il soggetto. Tutto questo può riaccendere una possibilità per un nuovo investimento libidico della realtà da parte del soggetto depresso, che così può ancora aprirsi al nuovo, al diverso, sperimentare e sperimentarsi in nuove strade, riprendere il proprio cammino di vita (Lolli 2009: 33).
Nella melaconia ancora una volta la condizione è del tutto differente. Il soggetto è solo, nudo, ritirato in se stesso. Il suo Io si è reso deserto e vuoto; il dolore di esistere sembra essere insensibile ai fatti della vita, che a loro volta sembrano non fare altro che conformarlo (Lacan 1974: 777).
ln breve, nella depressione il dolore ha in sé ancora una possibilità di riparazione, possibilità di riparazione che è assente, invece, nella melanconia, in cui anche il dolore sembra essere inutile e privo di senso, estraneo ad ogni forma di ricostruzione (Lolli 2009: 35).
La depressione, come espressione del dolore psichico, più di ogni altra forma di disagio, ci pone di fronte al limite strutturale della parola, ci confronta con il fatto che la parola non può esprimere tutto, tutta la complessità della natura umana, nel senso che la complessità dell’esperienza umana non può essere tradotta integralmente in parola.
Ogni depresso vive in prima persona l’impotenza insita nella sua condizione psicologica e nello stesso tempo l’inadeguatezza del proprio linguaggio, come modalità espressiva, nel tentare di comunicare l’intensità del dolore che prova, un dolore che, non trovando un riscontro fisico, non localizzandosi nel corpo, tende ad essere sottovalutato da chi si trova a raccoglierne il lamento, quasi a volerne mettere in dubbio l’autenticità, attribuendo ad esso minore dignità rispetto a quella che si attribuisce, di solito, al dolore fisico.
Oggi, sempre più frequentemente, la depressione viene descritta come una malattia “moderna”: la società contemporanea sembra contribuire a produrre questa condizione molto più di quanto non faccia per abbatterla. Ed è in questo la sua contraddizione più profonda: l’atmosfera edonistica predominante che assurge a valore supremo, la realizzazione di sé a qualunque costo, la ricerca sfrenata del piacere immediato come surrogato della felicità, sono radicalmente ostili a qualunque forma di tristezza (Minois 2005: 305).
Come si può vedere, infatti, uno dei risultati delle trasformazioni sociali ed economiche che hanno mutato irreversibilmente l’organizzazione della vita nelle attuali società occidentali ed occidentalizzate, è stato l’incremento del numero di persone che soffrono del disturbo.
In particolare, quanto più l’umanità si distacca dal livello del soddisfacimento dei bisogni primari, quanto più le condizioni di sviluppo economico assicurano alla collettività il raggiungimento del livello certo di sopravvivenza, tanto più affiora, si manifesta nel vissuto sociale un disagio, un malessere di cui l’aumento di persone che soffrono di anoressia, bulimia, depressione, attacchi di panico, dipendenze varie si fa segno inconfondibile (Eherenberg 1999: 235), (Lolli 2009: 15).
Il depresso, poi, in genere è un incompreso: egli stesso non riesce a comprendere fino in fondo i motivi della sua tristezza. In più, ancora troppo spesso la società considera la depressione come una mancanza di volontà, un lasciarsi andare colpevole, un abbandono delle responsabilità, un po’ come accade per il suicidio, che a volte l’accompagna (Minois 2005: 306).
La depressione pone l’uomo di fronte al proprio limite, tanto più oggi, ove sembra che nulla sia più impossibile. Il tecnicismo e la complessità della vita nelle società moderne hanno allontanato progressivamente l’uomo dalla sua natura più vera e più intima, lo hanno esiliato in un mondo dove anche la parola sembra aver perso il suo significato, così unico per la specie umana.
Ciò che appartiene più intimamente all’uomo – la sua anima e tutta la complessità della sua natura e dei suoi significati – è considerato dalle moderne società espressione di debolezza, inefficienza, inadeguatezza colpevole, sacrificato sull’altare della realizzazione di sé lungo la via del successo e della “visibilità ”.
La società oggi non sembra più in grado di affrontare attraverso strumenti simbolici – gli stessi che da sempre hanno avuto il ruolo di riconciliare l’essere umano con gli eventi più brutali della sua esperienza terrena – questioni radicali della condizione umana, quali la morte, la malattia, la sofferenza (Ehrenberg 1999: 295), (Lolli 2009: 127).
In tal modo, una parte significativa dell’esistenza umana resta esclusa da ogni forma di elaborazione interiore e rappresentazione sociale, non considerata degna di essere condivisa in modo collettivo, relegata a faccenda privata, da risolvere nella riservatezza della propria intimità, al riparo da sguardi che non sarebbero in grado di tollerarne, reggerne l’incontro.
Tra queste cose, così poco degne di ogni espressione sociale, c’è il proprio dolore, il dolore dell’anima che, una volta andato perduto, dissolto il suo potere di rimandare ad un progetto trascendente che, seppur sconosciuto, era comunque in grado di dare a questa esperienza un significato, esaurita ogni capacità di rinviare l’individuo ad una dimensione interiore che ne giustificasse l’esistenza, appare privo di senso. Quando si mostra, perciò, lo fa nella sua forma più bruta, difficilmente sopportabile ed integrabile nell’esistenza umana, come aggressione al corpo, come assalto all’individuo, indifferente ad esso, sordo a ad ogni ragione (Lolli 2009: 128).
L’unica risposta possibile, perciò, sembra essere quella della negazione del dolore, il suo allontanamento; da qui il ricorso a mezzi farmacologici per ridurne la minaccia e favorirne un rapido dissolvimento: analgesia come segno della società contemporanea che si esprime in campo medico e mostra il suo riflesso in campo sociale.
Si consideri l’ampio sviluppo di farmaci antidepressivi capaci d’incidere specificatamente su ogni sintomo della depressione, per attutirne le conseguenze in campo sociale e per allontanare ogni possibilità di elaborazione interiore a livello individuale (Ehrenberg 1999: 188, 249).
In tal modo, il soggetto può accedere ad una realtà parallela, ove ogni percezione spiacevole viene ad essere annullata. Il consumo spesso incontrollato di farmaci ne è un esempio. Il farmaco si colloca adeguatamente in tale dinamica di negazione e rigetto del dolore, capace di promettere uno stato di benessere per il soggetto, in linea con quel benessere ricercato e perseguito dalla società.
D’altro canto, la maniacalità della società moderna nega ogni significato al tempo e riduce lo spazio per ogni elaborazione interiore del dolore e del significato dell’esperienza, se non conformando ogni domanda all’unica risposta possibile, quella dell’efficienza, della produttività e del consumo.
Da qui il diffondersi del disagio, del vissuto di estraneità dell’individuo, che può ricorrere ad altre forme di analgesia, rappresentate dalle dipendenze, come tentativo di riempire un vuoto che neanche la parola sembra ormai in grado di riempire.
Lo svuotamento della parola come mezzo espressivo del dolore, la perdita del suo significato d’incontro con l’altro, di comunicazione, ascolto e condivisione, spiega il tentativo inconscio del depresso di localizzare sul corpo quel disagio che altrimenti sfugge ad ogni possibilità di definizione, un tentativo di dare a questo dolore così ineffabile una dignità, una concretezza (manifestazioni psicosomatiche come equivalenti depressivi).
Le parole non riescono ad illustrare, a descrivere questo dolore, che trova proprio nell’anima la sua sede, la sua espressività ; non riescono a circoscriverlo nella sua profondità : ecco, perciò, la separazione di chi è depresso dal resto della comunità, ecco il suo scivolare lento, ma inesorabile, nel silenzio.
La vanificazione della parola nel suo significato più profondo determina così due conseguenze: da una parte la comunicazione del dolore diviene un lamento, una forma di rassegnazione che non attende più dall’altro alcuna risposta; dall’ altra, ciò che reclama di essere detto e che non può essere detto trova espressione parziale nell’atto, come espressione esteriore, atto che si esprime in un gesto, in un manierismo, in una posa, fino ad un’azione autolesiva, come estrema e disperata richiesta d’aiuto.
Sospesa la parola, il corpo si pone in primo piano, il corpo nella sua postura di chiusura, il corpo nel suo significato fisico di “essere nel mondo”, nel suo dolore rappresentato in maniera plastica, immobile, oppure in maniera instabile, improvvisa, attraverso scatti, gesti afinalistici, autolesivi, fino al tentativo di suicidio, vissuti sempre sul solo registro ancora possibile dell’esteriorità, dell’espressività corporea, ma destinati ad esaurirsi nello stesso silenzio privo di parole da cui sono scaturiti, dove si è persa ogni possibilità di comunicazione, di ascolto, di scambio con l’altro (Lolli 2009: 8).
Di fronte a questo fallimento della parola, dove all’atto viene chiesto il compito di esprimere la sofferenza, il trattamento psicoanalitico chiede al depresso di ridurre il ricorso all’atto e di privilegiare l’uso della parola; gli viene chiesta una riflessione sulla propria storia, il blocco della compulsione all’azione e la possibilità di affidarsi al potere straordinario della parola (Gabbard 1995: 216).
Da un punto di vista psicodinamico, si può dire che oggi ciò che è caratteristico nel rapporto tra l’individuo e la società non è più la capacità di obbedire a regole ben precise, bensì quella di ottenere la massima espressione di sé. L’individuo nella società attuale non si trova più regolato secondo un’ordine esterno, non gli viene più richiesto di conformarsi ad una legge, la cui infrazione genera sensi di colpa, bensì gli viene richiesto di fare appello alle sue risorse interne per raggiungere quei risultati in base ai quali verrà valutato e, in base al giudizio che ne deriva, ottenere un adeguato o inadeguato concetto di sé.
Oggi non è più il conflitto nevrotico tra la norma e la sua trasgressione, con conseguente senso di colpa, a creare il disagio psichico, bensì, in una società ove non è più presente una norma, poiché tutto diviene possibile, il nucleo depressivo si costituisce intorno ad un vissuto di inefficienza, di inadeguatezza per ciò che si potrebbe fare e che non si è in grado di fare, o non si riesce a fare, secondo le attese collettive, in base alle quali ciascuno misura il valore di se stesso (Ehrenberg 1999: 227).
Si assiste ad un cambiamento strutturale della sofferenza psichica, che si esprime in un mutamento della sintomatologia, ove alla tristezza, al dolore morale e al senso di colpa si associano, fino a divenire preminenti, forme di ansia diffusa, inibizioni, insonnia, difficoltà relazionali di vario genere (Rossi Monti 2008: 143). Tutto ciò è espressione della fatica che l’individuo sperimenta ad essere se stesso, o della rinuncia ad essere se stesso per seguire i modelli di efficienza che la società impone, ove il disagio psichico tende ad esprimersi nei termini di patologia dell’azione. Il suo asse sintomatologico, infatti, si sposta via via dalla tristezza all’inibizione, alla perdita d’iniziativa, in un contesto sociale per cui “realizzare iniziative “ rappresenta il criterio decisivo per “misurare” e “siglare” il valore di una persona (Ehrenberg 1999: 254) .
Conclusioni
La depressione insidia l’individuo come un tempo la colpa minacciava l’uomo angosciato dal conflitto, e prima ancora l’anima rivolta a Dio era minacciata dal peccato.
Oggi si può dire che la depressione è “un modo di vivere”.
L’evento cruciale del XX secolo è stato il confronto-scontro tra la nozione di “possibilità ”, “illimitata”da un lato, e quella di “non padroneggiabile” dall’altro. La depressione, con la sua parabola ascendente, è stata l’indicatore di questo scontro e delle tensioni prodotte via via che la dimensione di “ciò che è permesso” è andata sfumando in quella di “ciò che è possibile”.
La depressione si pone proprio a livello di questo passaggio tra la sfera ideale delle possibilità illimitate che la scienza e la tecnica moderne sembrano promettere all’uomo, e ciò che è, invece, possibile: il limite umano dell’esistenza, così legato alla natura individuale di ciascuno.
Nel XIX secolo, la problematica della persona patologica si configurava nella bipolarità follia-delirio. Nel XX secolo, tale problematica si trasforma parallelamente alla trasformazione dei dilemmi umani in senso di colpa, dilemmi tanto più laceranti quanto più il soggetto tenta di affrancarsene.
Nel XXI secolo, la patologia sembra essere più legata alla responsabilità del soggetto, un soggetto oramai affrancato dalle “leggi dei padri”, dai vecchi codici di obbedienza o conformità, un soggetto che si crede artefice della propria vita, mentre ne è solo il “soggetto”, nel duplice significato di attivo e passivo (Ehrenberg 1999: 147, 263, 283, 315).
La depressione si situa proprio all’interno di questa illusione di “onnipotenza”, ricordando all’individuo il limite del suo essere uomo, al di là delle potenzialità apparentemente illimitate della scienza e di un tecnologia sempre più sofisticate, che sembrano voler far coincidere i termini impossibile-possibile, ed ancora, sembrano schiudere all’uomo orizzonti sempre più ampi di libertà pressoché illimitata.
La depressione è lì a ricordare all’uomo la sua umanità e il suo essere sì “proprietario” di se stesso, ma all’interno sempre della sua caratteristica di creatura terrena. La depressione è la prova che ciò che definisce l’essere umano non è esorcizzabile, non è eliminabile, perché ciò che definisce l’uomo, in altre parole, è vincolato ad un sistema di significati che lo trascende e lo costituisce allo stesso tempo. Come fa notare Ehrenberg, la dimensione simbolica, che un tempo era monopolio della religione e dava senso all’inesorabilità del nostro destino, oggi caratterizza una specie umana riconoscibile non solo attraverso la propria storia, ma anche attraverso un piano biologico nei termini di “biologia della mente”, una biologia della mente che informa così intimamente il nostro essere umani, una biologia che segna il limite di ciò che è immodificabile e immanipolabile (Ehrenberg 1999: 318).
La depressione ci ricorda che il nostro essere uomini non può essere superato; possiamo anche ridurre al minimo i nostri limiti con il più ampio dispiego di risorse a nostra disposizione, ma non possiamo travalicare questi limiti: c’è un margine irrinunciabile che non può scomparire.
Se Freud pensava che l’uomo diventasse nevrotico poiché incapace di tollerare i limiti imposti dalla società (Freud 1930: 223), oggi si può dire che l’uomo diviene depresso perché non riesce a sopportare l’illusione che tutto è possibile (Ehrenberg 1999: 318).
L’uomo, liberato dai vincoli della “legge dei padri” e dagli interdetti imposti dal Super Io, è comunque un uomo, con i suoi limiti, con le sue caratteristiche, una creatura che si trova sola con se stessa nell’illusione di poter realizzare tutto.
La depressione è proprio la caduta di questa illusione, è la prova dell’impossibilità di ridurre del tutto la distanza tra sé e sé da parte dell’uomo, all’interno della propria esperienza esistenziale (Ehrenberg 1999: 219).
Oggi i termini motivazione, progetto, efficienza, risultato, comunicazione pervadono la nostra esistenza. La depressione è l’antitesi di tutto questo: è patologia del tempo perché l’individuo depresso non si proietta nel futuro; è patologia della motivazione perché l’individuo depresso è privo di energia; è patologia dell’efficienza perché l’individuo depresso è rallentato, le sue parole sono stentate, egli non fa progetti e non comunica. Il soggetto depresso è l’antitesi di ogni forma di socializzazione in chiave moderna.
La depressione è il prezzo da pagare lungo la difficile strada che la società sembra indicarci per realizzare noi stessi, tra l’illusione di una libertà senza limiti e della disponibilità dei mezzi per raggiungerla, e i limiti imposti dalla realtà e dalle nostre caratteristiche umane ed individuali.
La depressione, in ultimo, è anche il segno della consapevolezza di se stessi, che rinuncia a spegnersi per seguire le facili mode del consumo e della felicità a portata di mano, è il segno della nostra specificità, della nostra capacità di ragionare e di riflettere sul senso della nostra esperienza. Come dice Minois: “la grandezza dell’uomo sta anche nelle sue ferite” (Minois 2005: 325).
NOTA:
*L‘Altro, con la “A” maiuscola indica, secondo l’insegnamento di Lacan, ciò che egli definisce l’interlocutore vero del soggetto, colui che il soggetto non conosce ma a cui, in modo inconscio, rivolge la sua parola, a cui rivolge le sue questioni. Va distinto dall’altro con la “a” minuscola, il partner immaginario del soggetto, il suo simile, colui con cui il soggetto entra fisicamente in contatto.
BIBLIOGRAFIA
Ehrenberg A. (1998), La fatica di essere se stessi, Einaudi Editore, Torino, 1999.
Freud S. (1930), Il disagio della civiltà , OSF 10, Boringhieri, 1978.
Gabbard G. O. (1994), Psichiatria psicodinamica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995.
Gozzetti G., Cappellari L., Ballerini A., Psicopatologia fenomenologica delle psicosi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999.
Kandel E. R., Schwartz j. H. (1998), Principi di neuroscienze, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2000.
Kaplan H. I., Sadock B. J., Grebb J. A. (1995), Psichitria, Centro Scientifico Internazionale, Torino, 1997.
Lacan J. (1974), Kant con Sade, in: Scritti, Einaudi Editore, Torino.
Lolli F. (2009), La depressione, Bollati Boringhieri Editore, Torino.
Minois G. (2003), Storia del mal di vivere, Edizioni Dedalo, 2005.
Noback C. R., Strominger N. L., Demarest R. J. (1996), Sistema nervoso, Masson, Milano, 1999.
Rossi Monti M., (2008), Forme del delirio e psicopatologia, Raffaello Cortna Editore, Milano.
Snyder S. H. (1986), Farmaci droghe e cervello, Zanichelli Editore, Bologna, 1989.