Aby Warburg
Tr. it., Adelphi, Milano, 1988
Tit. orig.: Schlangenritual, ein Reisebericht
“Il telegrafo e il telefono distruggono il cosmo. Il pensiero mitico e il pensiero simbolico, nel loro sforzo per spiritualizzare il rapporto fra l’uomo e il mondo circostante, creano lo spazio per la preghiera o per il pensiero, che il contatto elettrico istantaneo uccide.”
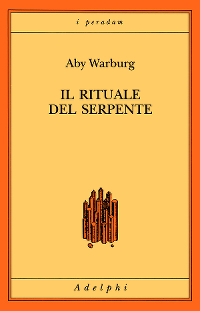 Questo può forse essere considerato il testamento spirituale di Abi Warburg, uno degli uomini che ha maggiormente influenzato la visione della storia dell’arte del XX secolo. Con queste parole infatti termina la conferenza che egli tenne nel 1923 ai medici e ai pazienti della casa di cura Bellevue di Kreuzlingen, diretta dallo psicoanalista Binswanger, di cui era ospite a causa di gravi crisi nervose. Binswanger, già assistente di C. G. Jung e amico di Freud, profondamente interessato dapprima alla fenomenologia husserliana e quindi all’ontologia fondamentale di Heidegger aveva trasformato la psicoanalisi classica in un’“analisi esistenziale”, un’analisi dell’essere-nel-mondo, attenta al significato della sofferenza ma anche alla necessità interiore di colui che la vive. La clinica, grazie alle particolari modalità terapeutiche, proprio come il celebre sanatorio descritto nella Montagna incantata di Thomas Mann, era frequentata dalle figure più significative della cultura europea dell’inizio del XX secolo.
Questo può forse essere considerato il testamento spirituale di Abi Warburg, uno degli uomini che ha maggiormente influenzato la visione della storia dell’arte del XX secolo. Con queste parole infatti termina la conferenza che egli tenne nel 1923 ai medici e ai pazienti della casa di cura Bellevue di Kreuzlingen, diretta dallo psicoanalista Binswanger, di cui era ospite a causa di gravi crisi nervose. Binswanger, già assistente di C. G. Jung e amico di Freud, profondamente interessato dapprima alla fenomenologia husserliana e quindi all’ontologia fondamentale di Heidegger aveva trasformato la psicoanalisi classica in un’“analisi esistenziale”, un’analisi dell’essere-nel-mondo, attenta al significato della sofferenza ma anche alla necessità interiore di colui che la vive. La clinica, grazie alle particolari modalità terapeutiche, proprio come il celebre sanatorio descritto nella Montagna incantata di Thomas Mann, era frequentata dalle figure più significative della cultura europea dell’inizio del XX secolo.
La conferenza, letta da Abi Warburg in occasione delle sue dimissioni, doveva essere ad un tempo la testimonianza della sua guarigione e del cammino di autoguarigione che egli aveva percorso: essa riassumeva le sue riflessioni sul materiale antropologico da lui raccolto circa trenta anni prima.
In quel periodo, stanco e preso da disgusto per la storia dell’arte estetizzante e le considerazioni formali dell’immagine che gli sembrava conducessero soltanto a uno sterile chiacchericcio, aveva intrapreso un viaggio nel New Mexico dove era entrato in contatto con la cultura degli indiani Pueblo. Rimase fortemente impressionato dai loro riti cerimoniali e dal potere che essi attribuivano alle immagini: ebbe l’impressione di essere entrato in contatto con uno stadio di cultura caratterizzato da sincronia di civiltà logica e causalità magico-fantastica. “I Pueblo si trovano a metà strada tra magia e logos e lo strumento in cui si orientano è il simbolo” (p. 28).
In particolare si interessò alla danza delle Antilopi di San Idelfonso, un pueblo nei pressi di Santa Fé, in cui ravvisò un comportamento tipico della cultura dei cacciatori e un esempio dello stadio simbolico del pensiero degli indiani Pueblo. I danzatori indossavano la maschera dell’antilope e imitavano le sembianze e i movimenti degli animali per riuscire a sopraffarli attraverso una forma di magia mimetica, secondo una logica assolutamente diversa da quella occidentale dell’aggressione. L’indiano infatti non riconosce all’uomo una superiorità sull’animale perché guardando animali come l’antilope, pura velocità, o l’orso, pura forza, vede in essi degli archetipi (o antenati totemici) e arriva a concludere che “gli uomini sanno fare in parte ciò che l’animale è interamente” (p. 31). L’imitazione della pantomima era dunque un atto cultuale che comportava la perdita di sé e l’ampliamento della dimensione naturale umana per entrare in contatto con la forza soprapersonale della natura a cui appartiene l’animale.
Guardando le danze mascherate dei Kachina di Oraibi legate alle festività periodiche dei coltivatori e destinate a propiziare un buon raccolto, assistendo al culto dello spirito dell’albero, vero symbolon (anello di congiunzione tra l’uomo e le forze ctonie in quanto le sue radici affondano nella terra), Warburg sentì di entrare in contatto con il patrimonio religioso universale dei popoli primitivi. Quelle danze magiche dal puro carattere demonico che rappresentavano il nascere e il morire della natura gli fecero ricordare la forza drammatica della tragedia classica nella sua dualità di coro tragico e dramma satiresco innestati in un unico ramo.
La forma estrema di approccio magico alla natura gli sembrò si potesse trovare presso gli indiani Moki, nella danza con i serpenti vivi. Il serpente è infatti per gli indiani un antenato totemico e una divinità metereologica presente nelle leggende cosmologiche delle origini. Queste raccontano di Ti-yo, l’eroe progenitore, che intraprende un viaggio per trovare le sorgenti dell’acqua e, dopo aver attraversato la kiva dei sovrani degli inferi e le due case del sole ad occidente e oriente, riceve infine nella grande kiva dei serpenti il baho magico per provocare la pioggia. Torna quindi alla sua tribù con due fanciulle-serpenti da cui nasceranno figli serpentiformi.
I Moki eseguivano in agosto, il periodo critico della siccità, una complessa danza cerimoniale: indossando ornamenti a sonagli si accomunavano ai serpenti per invocare un temporale tramite la loro potente mediazione. I serpenti d’altro canto venivano catturati nel deserto, sottoposti come gli iniziandi ai misteri a riti di purificazione in acqua consacrata, e infine scagliati su una pittura fatta con la sabbia rappresentante dei serpenti-fulmini, in modo da entrare nella pittura e mescolarsi con essa. Warburg nota come i danzatori e l’animale vivo formassero una magica unità e che nelle cerimonie gli indiani sapessero trattare con tale abilità il serpente a sonagli, il più pericoloso fra tutti gli animali, da riuscire ad ammansirlo senza ricorrere alla violenza, inducendolo a partecipare docilmente o quantomeno senza manifestare la sua natura di predatore – purché non provocato – a un rituale della durata di giorni (p. 46).
Questa manifestazione magico-religiosa è ricollegabile secondo Warburg ad un antichissimo culto del serpente che si perde negli strati più profondi del pensiero primitivo, alla radice stessa della simbolizzazione. La paura istintiva e primordiale per il più pericoloso degli animali non dà origine soltanto a una risposta reattiva automatica, ma crea uno spazio di pensiero immaginativo da cui emerge lo zôon symbolikón , l’animale simbolico in cui si incontrano l’elemento ctonio e l’elemento uranico: il serpente diviene il simbolo vivente che con un processo metaforico è messo al posto del fulmine, evocato attraverso il rito propiziatorio.
Il serpente rappresenta, a Babilonia come nell’Antico Testamento, lo spirito del male e la tentazione; nella Grecia arcaica è lo spietato divoratore sotterraneo o il giustiziere degli dei (vedi il serpente ctonio del crepaccio di Delphi o i serpenti che stritolano Lacoonte con i suoi figli) in un mondo dominato dalla vendetta, senza giustizia e senza misericordia. I culti orgiastici dionisiaci in cui si diceva le menadi danzassero con serpenti intorno al capo e alle braccia terminavano con un sacrificio cruento. Proprio la redenzione dal sacrificio cruento permea, secondo Warburg, come un intimo ideale di purificazione, la storia dell’evoluzione religiosa da Oriente a Occidente e il modo di porsi in relazione con il serpente può essere visto come indice dell’evoluzione della religiosità dal feticismo a pura religione di salvezza. Come dicono gli indiani, il serpente non rappresenta solo il morso letale che annienta, è anche il simbolo della rinascita dalla malattia e dalla morte, grazie alla sua capacità di entrare sottoterra e riemergerne e grazie alla capacità di mutare pelle. Questo aspetto salvifico del serpente è chiaramente presente anche nel mondo classico: nel tempio di Asclepio a Kos alcuni serpenti vivi erano oggetto di culto e lo stesso Asclepio è raffigurato con un serpente attorcigliato al suo bastone a simbolizzare l’anima dipartita del defunto che riappare sotto la sua forma di serpente.
Il culto del serpente sarebbe per Warburg una reminiscenza di un antichissimo simbolo, refrattaria a ogni tentativo di sublimazione religiosa. Anche nell’ a ntico t estamento il serpente, nonostante fosse riconosciuto causa di male e di peccato per il genere umano, tuttavia continuava ad essere idolatrato.
Le immagini tratte dal cerimoniale degli indiani Pueblo mostrerebbero come le danze mascherate siano la formulazione primitiva e pagana della risposta all’immane e tormentoso interrogativo intorno alla causa prima delle cose. Di fronte alla minacciosa incomprensibilità dei fenomeni della natura l’indiano cerca di trasformarsi egli stesso nella causa di tali eventi e la danza mascherata sarebbe appunto una causalità danzata.
Rispetto a questo stato primitivo di religione, cioè di unione tra uomo e entità estranea che si manifesta attraverso il simbolismo della maschera, il segno dell’evoluzione consisterebbe in una forma nobilitata di mascheramento, in una spiritualizzazione: in breve, nel passaggio da un simbolismo reale, corporeo, tangibile a un simbolismo mentale che si esprime in una mitologia linguistica sistematica.
Warburg, come spiega Ulrich Raulff nella postfazione, era entrato in contatto con la “Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft” pubblicata da Moritz Lazarus e Heymann Steinthal, vera fucina di idee e di scambio intellettuale, grazie alla quale erano state poste le basi della moderna antropologia, e che attraverso le indagini folkloristiche ed etnologiche cercava soprattutto di comprendere l’uomo creatore di simboli. Aveva inoltre conosciuto Cassirer che proprio nel 1921 aveva scritto una conferenza su “Il concetto di forma simbolica nella costruzione dello spirito” in cui aveva descritto lo “sviluppo dell’autocoscienza religiosa” illustrandolo a partire dall’atteggiamento nei riguardi delle immagini: dall’approccio magico-demonico alla contemplazione estetica. Warburg, avendo compreso attraverso la propria personale esperienza l’enorme potenziale terapeutico di tali idee, si era impegnato a diffonderle anche a Bellevue.
Il saggio su “il rituale del serpente” indica come il drammatico destino culturale dell’uomo sia ad un tempo anche il cammino di guarigione dalla umana sofferenza. Cammino difficile e sempre reversibile che deve essere percorso sia sul piano universale che individuale. Esso comporta un tentativo di passaggio dalla violenza del sacrificio cruento all’“immedesimazione mimico-mimetica” e da questa al pensiero puro che sa sottrarsi alla tirannia dei sensi e della paura.
