Roberto Calasso
La tavoletta dei destini
Adelphi edizioni
2020 pp. 146
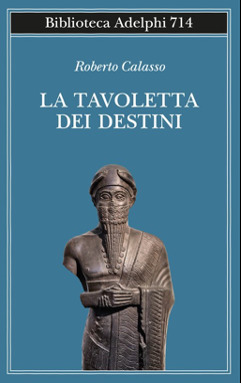 Roberto Calasso, anche in questo libro, l’XI di altri 10 libri, tutti invisibilmente connessi, racconta storie di uomini, di dei, di destini. Si tratta di storie antidiluviane, cha appartengono alla cultura sumerico accadica, eppure nei millenni, nei secoli, negli anni e in luoghi diversi, ritroviamo analoghi personaggi, avventure simili e destini che si intrecciano. E ci sorprendiamo di cogliere impensate corrispondenze in un passato capace di trasmetterci parole parlanti.
Roberto Calasso, anche in questo libro, l’XI di altri 10 libri, tutti invisibilmente connessi, racconta storie di uomini, di dei, di destini. Si tratta di storie antidiluviane, cha appartengono alla cultura sumerico accadica, eppure nei millenni, nei secoli, negli anni e in luoghi diversi, ritroviamo analoghi personaggi, avventure simili e destini che si intrecciano. E ci sorprendiamo di cogliere impensate corrispondenze in un passato capace di trasmetterci parole parlanti.
L’asse intorno a cui si avvolgono le storie è uno strano incontro. Sindbad il marinaio, protagonista dei sette leggendari viaggi e altrettanti naufragi raccontati nelle Mille e una notte, si era risvegliato in una strana incoscienza dopo il suo ultimo naufragio e aveva perso la rotta e i punti cardinali. Accanto a lui c’era un vecchio adusto, Utnapishtim (colui che ha trovato la via), l’unico sopravvissuto al Diluvio e che da millenni viveva da solo a Dilmun, un luogo magnifico ma lontano da ogni vita, aspettando di poter raccontare le storie a qualcuno che le volesse ascoltare. Il vecchio Utnapishtim, che sa tutto di Sindbad, comincia dunque a raccontargli le storie di prima del Diluvio. Parla degli dèi, alcuni superiori altri inferiori, che camminavano sulla terra finché, esasperati dalla fatica quotidiana del vivere, pensarono di crearsi dei sostituti: gli uomini. Ma per creare dei viventi era necessario un sacrificio e un dio doveva essere ucciso.
Fu chiamata Mami, la levatrice, che entrò nella camera del destino assieme a Ea, il dio che regnava sull’Apsu, lo stato illimitato delle acque dolci dal quale si poteva accedere al regno dei morti. Ea disse le parole decisive: “che gli uomini portino il peso degli dèi”(p.6). Fu scelto Geshtue e gli Anunnaki, gli dèi superiori, lo uccisero tutti insieme bagnandosi nel suo sangue e purificandosi poi nell’acqua di Ea. “E quell’atto doveva accadere in un certo luogo: lungo il Durmahu, quel vincolo, quella corda, quell’asse che lega il cielo alla terra” (p.16). Con il sangue di Geshtue penetrò uno spirito nell’argilla e Mami impastò l’argilla rigata di sangue. Ne fece sette pezzi che collocò a destra e sette a sinistra e in mezzo un mattone che tagliò a metà e a cui accostò i pezzi di argilla che a poco a poco cominciarono ad accoppiarsi, mentre Ishtar, la dea dell’amore e della bellezza, l’astro della sera e del mattino, osservava compiaciuta. Anche Sindbad, quando era a Bagdad, prima di incontrare Sindbad il marinaio, non faceva altro che portare grossi pesi sulla testa, dal mattino alla sera, ed era chiamato Sindbad il Facchino. La storia di dèi e di sostituti che portano i pesi lo riguarda!
Ma gli dèi Anunnaki presto si infastidirono degli uomini che si moltiplicavano, facevano rumore e disturbavano sì che decisero di rivolgersi a Namtar, che si occupava della morte, affinché risolvesse il problema inviando una peste sulla terra e, se non bastava, carestia e siccità. Accadde allora che le madri mangiassero le figlie e le figlie le madri. Mentre gli Anunnaki erano sempre più irritati e il dio Enlil annunciava il Diluvio, solo Ea non consentiva: “Posso calare la mia mano contro quelli che ho creato?”(p.24). Il Diluvio fu scatenato. Nella disperazione Utnapishtim cercò di ascoltare nel silenzio della notte, accanto al fiume, la voce di Ea che poteva giungere chiara al suo orecchio, sperando in qualche suggerimento. Ea, senza troppe parole, gli consigliò di costruire un battello cubico per salvare uomini e animali e di nascondere segretamente in una fossa, a Shuruppak, la sua città, le scritture sulle tavolette di argilla che testimoniavano quanto accaduto prima del Diluvio. Sindbad sarebbe stato l’ultimo dei pochi che avevano il compito di trasmettere quelle scritture.
Dopo il Diluvio, i rapporti tra gli uomini e gli dèi sarebbero rimasti difficili. Ea si trovò anche a dover spartire tra gli Anunnaki i me che erano poteri, leggi, regole e destini. Tutti gli dèi erano ebbri di potere, ma Ishtar, colei che era ovunque e in nessun luogo e che “somigliava al divino, che avvolge tutto e non si lascia isolare” (p.32) riuscì a parlare da sola con Ea e a congedarsi carica di 105 poteri. Invano Ea, risvegliatosi dall’ebbrezza dell’incontro, cercò di recuperarne alcuni.
- Ishtar non soltanto possedeva i me, ma li eseguiva. La sua parola diventava atto con facilità. (…) Anche per questo era così attraente e così terrorizzante. Se operava, poteva scatenare tutto ciò che è estremo. Per chi la sfiorava, tutto cominciava a vibrare. Poteva accadere di fronte al nemico o anche nel contatto fra due corpi. Senza Ishtar, nessun momento raggiungeva la durezza e il fulgore del metallo – (p.39).

Sindbad comincia a capire il senso di ciò che, al ritorno dai suoi viaggi avventurosi, aveva sempre sentito pronunciare da qualcuno: “non si sfugge al destino”. Anche le storie che Utnapishtim gli raccontava erano storie di destini a cui lui stesso aveva a volte partecipato, come un figurante. Col passare del tempo le storie si concatenavano come passassero su un unico luccicante nastro. Sindbad guardava il Dilmun, la distesa di migliaia di protuberanze di terra, di sabbia della stessa grandezza e colore che continuavano di là dell’orizzonte: – C’era un ordine, ma quale ordine? (…) Avevo la sensazione di vedere il tempo (…) Prima ho sentito terrore, poi una lieve, insensata euforia. E di nuovo terrore –. Utnapishtim alla fine disse – Ora sai che cosa è Dilmun – (p. 42).
Ogni potere, anche quello dei destini, aveva origine dalle acque dell’Apsu che Ea solcava. Anche Ishtar, pur se in possesso di tutti i me sottratti a Ea, quando volle scendere agli inferi e risalire, dovette scontrarsi con un potere più forte, quello della morte. Al pari di tutti gli altri dèi che per evitare la fatica avevano trovato dei sostituti, uccidendo un altro dio, anche Ishtar, dopo essere rimasta per tre giorni, sospesa ad un gancio, nel regno della morte, dovette trovare un sostituto che prendesse il suo posto. Scelse Dumuzi, il suo amante, figlio di un dio che, solo grazie alla sorella che si era offerta di sostituirlo, poté tornare sulla terra per la metà di ogni anno. Più tardi sarebbe scomparso Shukaletuda anch’egli un dio, figlio di Ea, che aveva osato amare la dea dormiente. “Senza la sostituzione la vita non riusciva a espandersi fino ai suoi estremi limiti, ma la sostituzione implicava la morte. Anzi, era la morte stessa a operare la sostituzione. O come uccisione o come scomparsa” (p.52). Tutti, anche gli uomini (che si chiamavano Teste Nere) erano preoccupati che l’ordine fosse scosso e che si dovesse ricorrere a una sostituzione. Se i presagi erano funesti per un re, si doveva trovare un sostituto che prendesse il suo posto e le sue funzioni, per un certo tempo, per poi andare al suo destino, cioè scendere nel “paese senza ritorno” portando con sé tutti i mali.
Utnapishtim non può smettere di raccontare a Sindbad le storie che un tempo tutti conoscevano, che erano incise sulle tavolette di argilla e che finirono sepolte sotto la sabbia e i detriti. Una di quelle storie, dopo tanti millenni, è ancora viva ai nostri giorni e continua a parlarci del destino e della morte.
Il superbo sovrano Gilgamesh si era battuto con Enkidu l’uomo della foresta, figlio di una gazzella e di un asino selvaggio, che presto divenne suo inseparabile compagno. Grazie al fascino di una prostituta di rara bellezza, Enkidu perse la sua selvatichezza, entrò nella città di Uruk e aiutò Gilgamesh a avvicinare l’inquietante Humbaba, un dio che al cielo preferiva la foresta dei Cedri, e a ucciderlo assieme al terribile Toro del Cielo. Ma gli dèi vollero vendicare il delitto ordito dai due amici. Toccò a Enkidu, nato dal silenzio, tornare nel silenzio. Gilgamesh non si rassegnava alla morte dell’amico che per lui era sceso negli inferi. Stravolto, andò da Siduri, la taverniera che sapeva ascoltare e conosceva gli uomini e le loro storie. Il grande sovrano iniziò con raccontarle le sue gesta gloriose e finì col confessargli l’unica cosa per lui insopportabile: la morte. Con sovrana sobrietà Siduri gli rispose: “quando gli dèi hanno plasmato gli uomini, hanno assegnato loro la morte. La vita l’hanno tenuta per sé” (p.78-79)”. Non c’era altro da aggiungere, ma Gilgamesh volle incontrare anche Utnapishtim, il solo sopravvissuto al Diluvio. Su indicazione di Siduri, lo raggiunse, dopo aver solcato le acque della morte e gli raccontò dei rischi e delle sfide affrontate. Parlava come Ishtar: fra gli dèi, solo loro avevano osato confrontarsi con il regno dei morti. Utnapishtim gli disse che le sue avventure non lo portavano a nulla: “gli uomini duravano quanto la libellula che per un giorno sbatte le ali sulle acque dell’Eufrate”. Ghigamesh si sentì sfinito proprio come il vecchio Utnapishtim. Ma Utnapishtim sentiva il cruccio di aver ingannato. Dopo il Diluvio, si era congedato dagli uomini che con lui erano saliti sul battello cubico ed era divenuto il solitario abitante del Dilmun, ma non aveva detto loro che erano “tutti destinati alla morte, per sempre. Anche Gilgamesh, un giorno (p.78)”.
Utnapishtim si sentiva superfluo. Dopo le storie antecedenti al Diluvio, c’erano soltanto storie di naufragi che finiscono tutte allo stesso modo, come quelle di Sindbad, che pure, con la sua presenza, gli fece comprendere che le storie sfuggono alla morte, come colui che le narra. Le storie avrebbero abitato anche in Sindbad che aveva conosciuto tanti mari, anche se doveva ancora conoscere l’Apsu perché “per capire gli dèi, i nomi, i destini, occorre passare dall’Apsu” (p. 87).
Anche Dante, per comprendere il divino e i destini, è passato per il regno della morte.
Apsu il dio delle acque dolci e Tiamat dea delle acque marine, erano i progenitori, ma avevano generato esseri turbolenti che impedivano il sonno di Apsu. Ea, suo figlio, risolvette il problema: addormentò suo padre Apsu con un filtro, lo spogliò dei talismani e lo uccise nel sonno. Il luogo liquido senza confini, che era stato il corpo di Apsu, ove in origine erano i me e la Tavoletta dei Destini, sarebbe divenuta la sua residenza, quella della sua sposa e del figlio Marduk. Quando Tiamat volle vendicare Apsu per mezzo degli undici figli a cui aveva inoculato veleno al posto del sangue, fu Marduk, istruito da suo padre, a uccciderla: strappò la Tavoletta che Tiamat aveva affidato al suo amante Kingu, vi appose il suo sigillo e se la pose sul petto. Marduk cominciò a stabilizzare il cosmo: i corpi dei due progenitori rivestirono il mondo, le costellazioni furono disposte sulla tela tenebrosa del cielo, il tempo fu diviso nei giorni dell’anno e dagli occhi di Tiamat sgorgarono il Tigri e l’Eufrate. Agli dei, ormai liberati da Tiamat, concesse di costruire sulla terra una nuova città: Babilonia! Dopo due anni di lavoro si potè contemplare l’Esagil, una città nella città, intorno alla quale c’erano quarantatre santuari dei Grandi Dei. Anche Marduk volle risiedere nell’Esagil, vi incluse tutti gli dei e ne fece degli epiteti, assorbendone le potenze.
Alla fine, per compiacere gli Anunnachi, che volevano sempre liberarsi dai pesi, volle plasmare uomini di sangue e ossa, e… il sangue doveva essere di un dio. Le storie si ripetono. Marduk aveva liberato, ma anche umiliato gli dei, anche Ea, suo padre. Allora gli dei, proprio i padri, si vendicarono e assalirono il figlio che voleva farsi loro salvatore, proprio nel suo tempio di Babilonia. Fu giudicato e nessuno seppe cosa accadde di lui. Sparì anche la sua statua che riapparve solo dopo alcuni anni come fosse stata restaurata. Ma Nergal, che sedeva negli inferi accanto alla sovrana Ereshkigal era implacabile: quando saliva sulla terra portava devastazione e nulla resisteva. Tuttavia Marduk aveva spostato, in un luogo a tutti ignoto, l’albero menu, chiamato carne degli dei, emblema del Re del mondo e, malgrado ogni distruzione, nulla sarebbe cambiato. “Non avrebbe cambiato la carne degli dei. Quanto agli uomini, ci sarebbe sempre stato un resto, pronto a riprendere gli stessi gesti, a compiere le stesse cerimonie”(p.102). La furia di Erra si placò solo grazie al suo saggio consigliere Ishum che lo persuase a lasciare un resto. Di quel resto gli dei avrebbero dovuto vivere. A quel resto apparteneva anche Babilonia, anche se un giorno anch’essa sarebbe stata distrutta e il resto si sarebbe spostato altrove.

Utnapishtim ricorda che dopo Marduk non apparvero più dei, “e vivere senza dei fu considerato non solo ammissibile, ma facile” (p.104). Ciò non portò bene. Il vuoto si espandeva in ogni direzione. Quando c’erano gli dei tutto aveva significato, se ne sentiva il peso e il destino era inciso anche sulle vittime sacrificali, poi gli dèi divennero irrilevanti, quasi oggetti di curiosità. Dominante e venerato era invece il caso che, inflessibile, non concedeva favori. Numerosi Anunnachi abitavano negli Inferi, la Grande Città, e non sarebbero risaliti nel cielo perché il passaggio era impraticabile. La Grande città vantava palazzi, templi e torri, ma c’era oscurità, il sole passava solo per giudicare, mentre gli abitanti si aggiravano nella polvere, coperti di piume come uccelli che non potevano alzarsi da terra.
Anche Sindbad sulla terra aveva visto una città simile, popolata di morti che sembrava inaccessibile. Chi aveva tentato di penetrarvi salendo sugli spalti, dopo qualche attimo, precipitava in terra in una risata convulsa. All’interno c’erano solo cadaveri. Alcuni sembravano imbalsamati, altri erano automi. Nella sala centrale su un grande letto c’era una donna splendente come la luna, e il primo uomo che si avvicinò per strapparle un monile ebbe la testa mozzata da un automa guerriero.
Prima del Diluvio, Uptanishtim, quando era re a Shuruppk, aveva ricevuto da suo padre una raccolta di sentenze e proverbi per come comportarsi con gli altri uomini, con gli dei, come governare… Molte di quelle parole finirono soffocate sotto la sabbia, e aspettavano che qualcuno le facesse respirare. La sola parola rimasta onnipresente, sulla bocca di tutti, dalle lavandaie ai re, era la parola destino. Poi, rivolgendosi a Sindbad “Senza quella parola tu non saresti oggi qui.” (p.116).
Sulla Tavoletta dei Destini era scritto l’ordine che dipendeva dal comporsi di un certo numero di elementi, i me, nessuno dei quali poteva mancare, neppure quelli terribili perché “la terra aveva bisogno di un vincolo, una corda, un ancoraggio al cielo (…) Se quel vincolo veniva a mancare, tutto oscillava e rovinava nel caso.” Ciò che è casuale incuteva terrore. La Tavoletta dei Destini, perennemente impregnata dalle acque dell’Apsu, era una potente gabbia cosmica contro il terrore. Era più potente degli dèi che avevano bisogno dell’ordine dato dai destini. Ne avevano bisogno anche gli uomini che potevano accedere ai destini solo attraverso gli dèi. A un certo momento gli uomini non parlavano più di dèi, invece parlavano sempre dei destini.
Tutta la vita Utnapishtim aveva riflettuto sui destini. Un giorno un sapiente Apkallu emerso dalle acque gli aveva detto: “La necessità non significa. Il destino significa. I destini sono un ordine che significa e si sovrappone alla necessità, punto per punto, passo per passo”. Tutti conoscevano un proverbio: Il destino morde come un cane e imprigiona come un vestito stretto. Meglio era vivere prigionieri del destino che in balia del caso, che terrorizzava gli dèi e gli uomini.
Tante le storie, che si intrecciano e si confondono, tante le domande di cui Utnapishtim nemmeno chiede più le risposte. Si rivolge a Sindbad: – So che stai per partire. È quello che hai fatto sempre. Anch’io continuerò a fare quello che ho fatto sempre: rimanere vivo – (pg.139).
Simili le ultime parole Di Socrate: “Ma è già l’ora di andar via, io a morire, voi a vivere. Chi di noi vada incontro ad una sorte migliore, a tutti è ignoto, fuorché al dio.”
