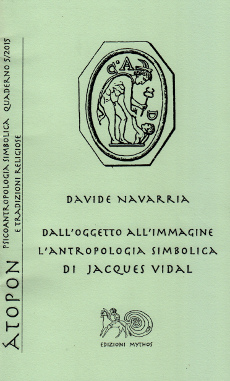(Traduzione dal francese di Maria Pia Rosati)
Per analizzare o comprendere un mito, bisogna talvolta distinguere i mitemi che lo costituiscono ed esaminare le grandi ridondanze che ne sono la chiave schematica o verbale.

Particolare da lekythos attica
Non sfugge a questa regola il mito di Orfeo con le sue numerose variazioni letterarie, pittoriche o musicali. Certamente come preludio alla mitoanalisi sarà necessario, seguendo Heidegger, sfogliare il lessico e scrutare le etimologie, ma senza dare ai nomi, e specialmente ai nomi propri, una importanza che rischi di mascherare il semantismo del racconto.
Talvolta Orfeo prende il nome di Dioniso, anche lui della Tracia, altre volte compare come Gesù Cristo, con il berretto frigio e la lira.
Dal nome di Orfeo deriva orfico, orfismo, orphéon… la qual cosa ci dà già due orientamenti semantici: il mistero iniziatico e la musica. L’etimologia aggiunge ancora altri elementi al quadro: tralasciamo il sanscrito, «tirato per i capelli», ribhus, il cantore, il bardo. Ricordiamo con Salomon Reinach orphnos, «sobrio», «oscuro», «notturno», ed ancora orphê – es: «la notte», «le tenebre», orphinos «scuro», senza voler arrivare a orphanos, «l’orfano», o il pesce teleosteo orphos.
Un passo ulteriore è possibile quando si organizza il racconto, quando le superstizioni e i riti si «letteralizzano» (A. Siganos) e quando si lavora con le sequenze del mito: tre secondo P. Brunel (1. Orfeo e gli Argonauti; 2. Orfeo ed Euridice; 3. Orfeo e le Baccanti), quattro secondo P. Grimal che aggiunge la «tomba di Orfeo». Brunel sottolinea giustamente che «l’avventura non è designata fin dall’origine: essa si organizza tardivamente a partire da un conglomerato di tradizioni diverse». Tale origine è del tutto relativa: designa semplicemente l’emergenza del linguaggio del mito, poiché un mito non ha mai un’origine assoluta e, come sottolinea Thomas Mann a proposito del mito di Giacobbe, si perde nel «pozzo del passato», cioè, per un antropologo, nelle strutture congenite del Sapiens. Se il cervello «secerne il pensiero come il fegato la bile» ogni mito è innanzitutto una secrezione interna! Inoltre ciascuna delle sequenze, che sono spesso “lezioni” di epoche molto differenti, arricchisce in qualche modo il mito, arrivando talvolta sovraccaricarlo fino a farlo cambiare di senso. L’arte dello studioso di miti consiste inizialmente nel collezionare lezioni, spillarle su delle schede (Cl. Lévi-Strauss), paragonarle, infine nell’interrogarsi su ciò che in una determinata circostanza d’epoca e di cultura produce un cambiamento nel mito.
Un ulteriore passo, questa volta decisivo, nella comprensione ci fa percepire il mitema centrale che tutte le avventure di Orfeo e dei suoi sinonimi ripetono: il motivo guida (leitmotiv) del mito. Non a caso abbiamo preso in prestito dalla musicologia un termine atto ad arricchire il vocabolario dello studioso di miti. Perché come vedremo (vedi tavola riassuntiva, pp. 20-21), tutte le avventure di Orfeo, dei suoi sinonimi e delle sue vicarianze gravitano intorno ad un leitmotiv permanente ed ossessivo: la nostalgia (da nostos = ritorno e algia orphéon e nella musica che nelle avventure del triste eroe (orphnos). = dolore) che si declina tanto nell’
Da Orfeo all’orfico
Esaminiamo le tre o quattro avventure di Orfeo, spesso figlio di un re Tracio e di una musa, Calliope, Polimnia o Clio.
1. Ciò che colpisce è innanzitutto la ridondanza, la “sincronicità ” del carattere iniziatico dell’eroe triste.
Nella prima avventura, quella degli Argonauti, Orfeo è il “caponavigazione”, e è descritto come iniziato ai misteri di Samotracia governati dai Cabiri, “grandi dei” dal nome segreto, interdetto al pari del nome YAHVE presso gli ebrei.
Nella seconda avventura, la più diffusa e popolare, quella degli amori infelici con Euridice, la discesa agli inferi è un’iniziazione in cui Orfeo apprende i segreti della nekuia (discesa agli inferi).
Nella terza avventura troviamo il ritorno in Tracia del vedovo inconsolabile che fonda una società segreta, interdetta alle donne, formata da uomini soli, iniziati.
Infine nella quarta avventura (secondo Grimal), la «tomba di Orfeo», il miracolo della lira che suona, di una testa che recita e canta, inizia, per così dire, l’«orfismo» sia metafisico che musicale. Dunque Orfeo, iniziato o iniziatore, è collegato con l’iniziazione in generale: cabirica, «orfica», thanatica ( da thanatos, per usare un neologismo).
2. Nel secondo gruppo sincronico di mitemi, le prove dell’iniziazione compaiono in dettaglio. Come abbiamo spesso osservato queste prove sono sia attive che passive. Orfeo è già pastor et agnus. Argonauta, governa gli elementi con il suo canto che supera quello delle temibili sirene. Mentre muove piangendo alla ricerca di Euridice doma Cerbero e i mostri infernali e incanta Ade e Persefone, le divinità degli Inferi.
Sventuratamente, al suo ritorno in Tracia, da dominatore diviene dominato, fatto a pezzi – come Osiride – dalle donne Tracie o folgorato da Zeus.
La quarta avventura, quella di Orfeo al di là della morte, non comporta prove.
3. Infine scopriamo il raggruppamento simbolico permanente, il più importante del percorso orfico: quello del nostos, del ri-torno.
Sia che l’Argonauta musico abbia la missione in Colchide di riportare l’anima di Frixos (colui che aveva fatto dono del famoso «vello d’oro» al re della Colchide Eeta), sia che nel dramma della cerca di Euridice lo sposo si ri-volti per rivedere la sua donna, malgrado la proibizione espressa dagli Dei, abbiamo sempre una infrazione all’ordine divino che ho chiamato il «peccato di Orfeo». Orfeo, vedovo inconsolabile nella terza avventura, ritorna al paese natale, la Tracia, dove lo attende la suprema passione. Infine, nell’avventura post-mortem, la «tomba di Orfeo», tra i resti del poeta fatti a pezzi e gettati nell’acqua, la testa incantata e la lira si arenano a Lesbo o sono riportati in Tracia per scongiurare la peste che affliggeva il paese.
4. Certamente non bisognerebbe dimenticare l’oggetto mitema: la lira (o la cetra) del musico inspirato. Fin dalla prima sequenza argonautica il figlio di Calliope – musa della poesia lirica e secondo Apollodoro, (Biblioteca, 1, 3, 4) madre delle Sirene – il cantore ispirato, accompagnato dalla cetra a nove corde (in onore delle nove muse) che egli avrebbe inventato e perfezionato, supera in dolcezza il temibile canto delle sirene e salva i suoi compagni dalla seduzione. È noto come la lira-cetra giochi un ruolo primordiale nella famosa sequenza della discesa agli inferi (Georgiche IV): doma Cerbero, sventa e sospende i supplizi infernali di Tantalo, di Issione, di Sisifo, infine seduce Ade e Persefone.
Se nella terza sequenza – la «passione» di Orfeo – è presente un minor numero di allusioni allo strumento musicale, questo riappare con forza nell’ultima sequenza, la «tomba di Orfeo», poiché sia la testa che canta miracolosamente sia la lira sfuggono alla dissoluzione nel fiume. All’anima di Orfeo fu assegnato per l’eternità il compito di incantare i Beati dell’altro mondo, mentre la lira è, in eterno, una costellazione del nostro cielo.
Lo stesso schema con i quattro insiemi sincronici ed il racconto diacronico si ritrovano identici in tutte le declinazioni del mito di Orfeo. Non si tratta di trovare Orfeo ovunque, ma di seguire la pista di eroi che sono stati esplicitamente paragonati all’inspirato eroe tracio o sospettati di orfismo.
Guardiamo innanzitutto alla costellazione dionisiaca.
Dioniso è il tipo della divinità posseduta da un aldilà trascendente. È certamente un iniziato attraverso il delirio mistico, è l’inventore della vigna e dell’ebbrezza che essa procura. Iniziato in Frigia ai misteri di Cibele, nelle vesti dell’adolescente Iacco guida danzando la processione degli iniziati ad Eleusi.
Costantemente nella sua leggenda compare la follia; talvolta egli la manda per punire (il dio colpì con la follia Licurgo, il re tracio che aveva tentato di catturarlo; ad Argo rese folli le figlie del re e tutte le donne;fece impazzire i pirati che volevano farlo prigioniero); altre volte lo stesso dio si abbandona piacevolmente nel corteo delle baccanti agli eccessi del delirio, oppure viene colpito dalla follia per la vendetta di Era. Dapprima iniziato, quindi consegnato alle lacerazioni della passione, anch’egli pastor et agnus. Il dio, soprannominato il «capro», travestito da fanciulla per sfuggire alla collera di Era, con il nome di Zagreus viene mutato in toro e infine dilaniato dai Titani mandati dall’implacabile dea (in questa sequenza del mito non resuscita la testa, ma il cuore palpitante che la dea Pallade ha recuperato e offerto a Zeus).

Mosaico pavimentale romano di età imperiale
Palermo, Museo Archeologico
La sequenza delle vicende di Dioniso-Zagreo riferisce una serie di episodi di ritorno (nostos): il dio dilaniato, sorta di «primo Dioniso» è resuscitato come fanciullo, addirittura come embrione, quando Zeus feconda Semele con il cuore del «primo Dioniso» e genera così il «secondo Dioniso», il «due volte nato». Altre lezioni fanno ancora intervenire tra il «secondo Dioniso» e il «primo Dioniso-Zagreo», un «terzo Dioniso»: Iacco (Bacco), l’adolescente danzante che guida le processioni di Eleusi.
Non dimentichiamo infine come la danza e i canti siano strettamente legati nelle raffigurazioni di Dioniso, inventore del vino e della folle ispirazione – mania – che Platone/Socrate celebrerà (con moderazione) in Leggi I e nel Fedro (244 ss.).
L’inventore della danza dilaniato dalle baccanti non è forse Iacco che guida e dà ritmo alle processioni di Eleusi? Non è colui che adotta nel suo corteo il dio Pan, suonatore della siringa? C’è dunque una stretta parentela mitemica, sovente esplicita, tra Orfeo e Dioniso/Zagreo/Iacco.
Un’altra parentela orfica, esplicitata chiaramente dagli affreschi e mosaici del paleo-cristianesimo latino, è quella tra Orfeo e Cristo. Notiamo innanzitutto (cosa dimenticata dal cristianesimo moderno alquanto storicista) che il cristianesimo delle catacombe – in cui del resto il Cristo buon Pastore è assimilato ad Orfeo portatore del cappello frigio e della lira – è fondamentalmente iniziatico nel suo cammino di «trasfigurazione dell’uomo peccatore», gravato della colpa di Adamo, in un «uomo nuovo». Nel cristianesimo originario questa trasfigurazione si fa per gradi – catecumenato, battesimo, conferma, eucarestia – molto simili ai gradi iniziatici (R. Aigrin, p. 695). Ad esempio i semplici catecumeni erano esclusi dalla « messa dei fedeli» (cioè dalla liturgia a partire dall’Offertorio). La classe dei catecumeni era essa stessa divisa in audientes e in competentes e il catecumenato durava da due a cinque anni (Concilio d’Elvira, 300).
Il secondo gruppo orfico di simboli, la «passione di Orfeo», è molto esplicito nel dramma cristico. La crocifissione, preceduta dalla flagellazione, e seguita dalla perforazione del cuore – da cui cola sangue ed acqua – è molto vicina alle «passioni» di Orfeo dilaniato dalle donne tracie o di Zagreus dilaniato dai Titani. Cristo stesso si dà come pastor e agnus: «mortuus et vivus idem sum pastor et agnus». Pastore come appare nel Salmo 23, in Ezechiele (34,12), Isaia(40,11), Luca (15, 37), Giovanni (10, 1, 16); agnello in Isaia (53, 7), Giovanni (1, 29), nell’Apocalisse (sub specie agni, 5, 6).
Quanto alla categoria orfica del «ritorno» essa è l’asse di ogni redenzione (dal lt. reddere = ritornare) cristiana. Ritornare al di là del peccato originale, ridiventare un «bambino piccolo» è il programma fondamentale del cristianesimo che si manifesta a partire dal profondo ed ingenuo inno di Venanzio Fortunato (600) Illud Ave… mutans Hevae nomen… fino alla sequenza fondamentale della vita del Cristo: la risurrezione, dopo una nekuia, una regressione nel limbo dove i precursori del Messia (Adamo, Abramo, Mosè, Giovanni Battista) aspettano la liberazione. Le apparizioni – alle Pie Donne, alla Vergine, ecc.– di Gesù e il mistero eucaristico manifestano proprio questo «ritorno» alla vita, questa «risurrezione» su cui poggia la fede dei credenti: la «presenza reale» che né il tempo né la morte possono più toccare. Jeans Canteins sottolinea questa nost-algia propria del Cristianesimo (cfr. Le retournement dans le Nouveau Testament) .
È superfluo segnalare l’importanza preminente della musica nel cristianesimo. Sin dalla sua più lontana origine, eredità della Sinagoga, il canto religioso (la schola) è attestato dallo stesso San Paolo nella sua Lettera agli Efesii (V, 19) e da Plinio il giovane nella sua famosa lettera a Traiano: «carmen Christo quasi deo dicere». Dal IV secolo le litanie, quindi i responsori e le antifone sono cantate ad Antiochia e poi a Costantinopoli e passano in Occidente a Milano, metropoli del canto corale, come testimonia Sant’Agostino. Dalla famosa riforma del papa Gregorio I (590-602) al Concilio di Trento del 1562 che incarica Palestrina (1577) del riordinamento della musica della Chiesa, la musica – Frau Musika come dice Lutero che la colloca proprio dopo la teologia – è al cuore delle preoccupazioni liturgiche dei cattolici (l’oratorio) come dei protestanti (la cantata).
L’organo diviene lo strumento musicale più religioso, come è riconosciuto da R. Wagner e da Pio X (Divini Cultus). Se le Chiese si separano e si dilaniano, la «veste senza cuciture» è pietosamente indossata da Buxtehude, Bach, Frescobaldi, Mozart, Bruckner, Franck, Messiaen, Poulenc e praticamente da tutti i musici dell’Occidente cristiano.
Gesù Cristo sarebbe dunque figura più orfica di Orfeo? Probabilmente poiché è importante non il nome proprio ma l’agire («espresso dal verbo»), e noi conosciamo meglio gli atti del Cristo, a noi vicini e resi familiari da tutta una vasta letteratura, che quelli del lontano musicista trace. Così l’aggettivo “orfico” precisa e supera la storia di Orfeo.
Non si sa molto storicamente di questo movimento orfico la cui origine si perde nella notte dei tempi (VI sec. a. C.) con alcuni frammenti di poemi orfici, ma si può constatare la coerenza di un corpo ideologico e simbolico accreditato da Euripide ed Aristofane, echeggiato dalla filosofia pitagorica e che struttura una parte notevole dell’opera di Platone e dei platonici. Attraverso questo vasto e perenne movimento pitagorico-platonico sono designati i grandi tratti del movimento «orfico».
Ritroviamo in esso, illustrato dall’opera di Platone, le tre grandi strutture mitemiche dell’impresa di Orfeo.
Cominciamo dalla seconda: le prove o la «passione orfica». Essa è presente nell’ascesi pitagorica come nell’etica platonica del dominio delle passioni del corpo (Fedro 246 a, 253 d) – thumos e epithumia – ad opera di un principio che le trascende, il Nous, l’anima previdente. Il Nous necessita per lo meno della temperanza (Gorgia 492 d) che Socrate oppone allo scatenamento delle passioni predicato da Callicle: «è necessariamente un compito difficile, un compito poco interessante fare l’auriga!» dice Socrate/Platone nel Fedro (246 b; vedi Fedone 67 b).
Questa ascesi sfocia naturalmente nell’iniziazione alla quale è consacrata tutta l’opera di Platone (Simposio 210 a): l’educazione (Leggi I), 643), l’ascesi, la temperanza non hanno senso se non conducono ad un “altrove” rispetto alla morte, al tempo, alla decrepitezza e alla decadenza di cui è simbolo il corpo (una prigione: soma = sema!). L’iniziazione è la conferma dell’anima nel suo essere e nella sua eternità (Fedro 245 a), luogo che le è proprio (Fedone 110 a, ss., Fedro 247 c, ss.).
Il motore e il metodo di questa iniziazione è esplicitamente il «ritorno» che Platone descrive con il nome di «reminiscenza» (Menone 81 d, Fedone 72 c, 81 b, Fedro 249 c).
Ogni vera conoscenza è ritorno al mondo eterno delle verità. Il ruolo dell’amore, nel Simposio, è «procreazione» (ritorno a ciò che non può perire) e generazione nella bellezza, cioè ritorno alla bellezza immortale. La famosa allegoria della Caverna (Rep. VII, 514 ss.) dice al pari della saggia Diotima: «Uno di questi uomini (incatenati) […] sarà stato liberato, forzato a sollevarsi, a volgere il collo, […] a guardare dal lato della luce».
Ogni educazione porta ad una iniziazione e ogni iniziazione è «ritorno», riconduzione.
Riconduzione, come ha messo in luce Henry Corbin, è anche il famoso twil, una maniera di leggere che riconduce i segni e i simboli del testo alla loro eterna sorgente, fondamentale presso tutti i platonici di Persia e i mistici e i sufi dell’Islam. Bisogna insistere ancora una volta (come ho già fatto a proposito dell’opera di Wagner, ma anche di Huysman, Meyrinck, ecc.) sul nostos orfico-platonico che è alla base di ogni processo iniziatico nel quale è presente la con-versione.
L’emblema è nella visione a specchio, nello specchio che ri-volge destra e sinistra di ciò che si guarda. In Platone l’allusione allo specchio (Fedro) permette di comprendere l’unità dell’anima.
Lo specchio è attributo di Dioniso, il «nato due volte» e permette al dio di vedere la pluralità di ogni cosa. Ritroviamo il ruolo didattico dello specchio in Plotino, Atanasio, Gregorio di Nissa, presso i Platonici musulmani, presso El Ghazali. In altre tradizioni, quella giapponese ad esempio, lo specchio Kagami è attributo della grande dea Amaterasu; in quella musulmana il cuore è lo specchio che rettifica ogni verità.
Un’arte della divinazione – cioè dell’appercezione delle verità profonde – basata sullo specchio è presente in Goethe (forse inspirata a una incisione di Rembrandt), in Lewis Carroll, in Mallarmé (nella sua Erodiade), in Gustave Meyrinck e in Cocteau, nel film Orfeo, in cui la «traversata dello specchio» è simbolo dell’accesso diretto al principio delle cose, a ciò che è «dietro lo specchio». La luna – lo specchio del sole – è assimilata alla Vergine Maria «specchio carnale » della divinità. Tale rivolgimento della visione comune delle cose è all’inizio di ogni iniziazione, poiché si tratta sempre di convertire il vecchio uomo rivolgendolo verso la sua essenza, la sua origine, la sua infanzia.
Infine troviamo in Platone che la musica, il coro (orphéon), è stata donata agli uomini dagli dei «con le Muse, e Apollo che guida il loro coro, e Dioniso». Il canto e la danza sono alla base dell’educazione, in quanto offrono, attraverso la bellezza di cui si fa esperienza in una bella postura o in una bella melodia, l’esperienza stessa dell’«eccellenza dell’anima e del corpo», e sono un «incantesimo per le anime» (Leggi II, 659 e). Platone insiste per la codificazione dell’educazione ad opera di una musica codificata, come nella mitica Egitto, mentre respinge tutte le arti dell’imitazione (Rep. III, 398).
Riguardo all’importanza che Platone dà alla musica dobbiamo notare che, come per i Pitagorici (Rep. VII 530 d), le leggi della musica (armonia) la scoperta delle proporzioni della quinta, della quarta e dell’ottava, sono le leggi fondamentali del mondo, cioè della fisica (acustica) e dell’astronomia (musica delle sfere). La musica pitagorico-platonica è dal lato dei numeri, delle scienze e lo resterà nell’educazione medioevale, nel quadrivium a lato della geometria e dell’astronomia.
Dunque tutto l’eudemonismo platonico e il suo passato orfico-pitagorico sono ben lontani dal separare il numero e la sua misura, misura del cosmos,dall’arte musicale, ultima delle «arti liberali».

1890 – Gustave Moreau
Parigi, Musée Moreau
Dall’Orfismo all’“orphéon”
Grazie ai chiarimenti portati al misterioso orfismo dall’immensa opera di Platone, possiamo approfondire ciò che collega l’orfismo all’eccellenza etica e pedagogica dell’orphéon, del canto corale e della musica. Tutta la corrente dell’estetica musicale nata da Platone non muore con il Medio Evo, ma prende una nuova vivacità in pieno Rinascimento fiorentino alla fine del XV secolo (con Marsilio Ficino (1499) il sapiente protetto da Lorenzo il Magnifico e Tommaso Campanella (1639) che alla fine della vita, emigrato, fu protetto da Richelieu) e all’inizio del secolo XVII che vede nascere l’Opera.
Ficino riprende la teoria platonica della «musica delle sfere» mettendo in parallelo l’astrologia e la musica che, nascendo dal soffio, è l’esperienza concreta dello Spirito.
Questa tesi sarà ripresa dai grandi teorici del rinascimento: Cornelio Agrippa, Paracelso, Lefèvre de la Boderie, Pontus de Tyard, Gohori, Pomponazzi, ecc., e infine Campanella, più misurato di Ficino, il quale elabora una teoria cosmologica delle molteplici armonie che superano di molto il nostro misero modello armonico terrestre. La teoria di Ficino, più competente musicalmente, è più psicologica, intimista; quella di Campanella – grazie al riconscimento delle molteplici armonie – è più universalista e nasconde qualche ambizione “cattolica” di riunire tutte le differenti gradazioni dei mondi.
E sullo sfondo della celebre Accademia fiorentina, con il passaggio in Francia di tali teorie attraverso la Pleiade, Baïf e Richelieu, si ricompongono, al di là della Cristianità definitivamente spezzata, gli elementi ancora vivi dell’Orfismo che all’inizio del XVII secolo vengono trasmessi all’Opera, il nuovo «orphéon». La nuova religione dell’arte, l’opera, e più in generale la musica, prende slancio e stabilisce il suo regno proprio dai due corni fiammeggianti della cristianità divisa: da una parte lo slancio iconoclasta della musica di Lutero, dall’altra lo slancio opposto, iconofilo del trionfalismo pittorico e plastico della Controriforma. Così mentre la musica protestante capta a suo uso e sacralizza arie profane, la pittura barocca della Contro-Riforma nel suo eccesso di virtuosità musicalizza, in certo qual modo, l’arte del dipingere.
La lira orfica della monodia sostituisce l’organo del corale, mentre la pittura scende sulla scena teatrale, si “mette in scena” come ancella della musica. La musica porta ai protestanti come ai cattolici, come a coloro che fuggono con orrore le mostruose sfigurazioni delle “guerre di religione”, la presenza stessa, sperimentata, se così si può dire, di un mondo al di là delle vicissitudini del concepimento e della morte, di un mondo paragonabile all’immobile mondo delle idee di cui sognava Platone e il platonismo: un mondo in cui – come dirà Gurnemanz – «il tempo diviene spazio», tempo che trionfa per la ridondanzainfinita la quale, permettendo la ripetizione («tempo ritrovato»!), abolisce le usure del tempo lineare. Già la musica ingenua incorona il refrain e il ritornello, il canto-piano si inebria di ripetizioni litaniche, e la polifonia scopre il contrappunto in cui le voci sono costantemente riprese.
La musica del tardo Rinascimento scopre il continuo dell’ostinato, della redicta, della ripetizione, delle sequenze. La monodia dell’opera resta fedele nelle sue arie alle riprese, ai refrains e inaugura la monotonia del recitativo in cui dietro l’azione temporale delle parole la musica ristabilisce la ridondanza musicale.
È significativo che le prime manifestazioni di questo stile nuovo (che colloca al secondo piano polifonia e ornamenti virtuosi per esaltare la monodia e, con Baïf, la «semplificazione orfica» intorno ad una favola) riprendano testualmente le sequenze di un antico mito di Orfeo (e specialmente la seconda sequenza: quella del dramma di Euridice perduta). Nel 1600 J. Peri e Caccini danno ciascuno la loro Euridice; nel 1607 Monteverdi mette in scena la sua favola in musica, Orfeo; l’oratorio di J. Landi, La morte di Orfeo è del 1620, nel 1647 si rappresenta a Parigi l’Orfeo di L. Rossi.
Esplicitamente presente alla nascita stessa del genere opera, Orfeo riappare direttamente o indirettamente ogni volta che questo genere ha bisogno di un rinnovamento: nel 1762 Gluck si oppone ai piccinisti (non a Piccini che egli stimava molto) rappresentanti delle derive che minacciavano il genere opera e ne facevano unicamente il luogo di virtuosità vocali, dimenticando il dramma per musica che lo fonda. Gluck, contro la virtuosità italiana, ritornava al linguaggio del cuore dei grandi fondatori della corte di Toscana e di Mantova. Fu ammirato nel XIX sec. da Berlioz, precursore della rivoluzione wagneriana, che disciplinava e regolava l’orchestra e le voci «secondo l’interesse e la passione», poiché «gli strumenti cantano allo stesso tempo che il cantante, soffrono le sue sofferenze, piangono le sue lagrime».
Il primato del dramma sulla tecnica del canto può leggersi nelle esitazioni e i cambiamenti dati da Gluck alle tessiture di Orfeo nelle differenti versioni: contralto-castrato nella versione di Vienna (1762), tenore nella versione di Parigi del 1774, e nel XIX secolo – con il consenso di Berlioz – alto femminile.
Ma cosa ne è di Orfeo nel periodo di reintensificazione dell’Opera caratterizzato dalla produzione di autori nati all’inizio del secolo (Berlioz 1803, Verdi e Wagner 1813, Gounod 1818) e dalle opere maggiori quali Don Carlos 1867), Aida (1871), I Troiani (1863), Tristano (1865), l’immenso e paradigmatico Ring(1869-1876), l’ultimo Parsifal (1882)?
I momenti decisivi dell’Opera (pieno barocco caro a Claude G. Dubois, ultimi bagliori delle luci del XVIII sec. con Gluck, Haydn e Mozart, infine «secondo Impero») erano quelli dell’apparato. Un «apparato» che denuncia se stesso in uno scrupolo a cedere all’apparenza. Il grande specialista del barocco che definiva quest’ultimo come «profondità dell’apparenza» precisa ancora la sua analisi svelando nello spettacolare barocco una «permeabilità dei contrari»; da qui infine una «incompletezza delle apparenze».
Profondità, voragine, incompletezza modellano il fondo, l’apertura, la completezza che sono proprio la musica, e soprattutto l’opera, il dramma per musica che collega intimamente il canto e le sfumature strumentali agli slanci della passione e del cuore. Il richiamo all’ordine musicale, all’ordine orfico si manifesta ogni volta che la musica – l’opera – è tentata di lasciarsi sedurre dalla virtuosità, l’ornamento, il gioco gratuito dei timbri; è proprio di Gluck, trova spazio nelle più profonde melodie di Mozart e permea tutta l’estetica wagneriana.
L’assenza nominale di Orfeo nell’opera del XIX secolo rinforza ancora la nostra tesi secondo la quale Orfeo si riduce a musica: egli è soltanto la lira e la testa che canta. Al contrario le arti figurative e letterarie della fine del XIX secolo e della prima parte del XX si impadroniscono a sazietà della sua immagine: Gustave Moreau rappresenta per lo meno quindici volte il musicista tracio e Rilke, Segalen, Anouhil, Cocteau si impadroniscono esplicitamente dell’eroe mitico.
Orfeo non è più nominato nelle opere della fine del XIX secolo, ma non per questo sono assenti il suo mito iniziatico, la sua passione, la sua nostalgia fondamentale e infine la sua assunzione nel canto e nella lira.
L’ultima rinascita orfica, quella dell’estetica e dell’opera di Richard Wagner, attesta costantemente la pregnanza dei suoi mitemi e del suo ethos. Orfeo tace il suo nome perché è divenuto la famosa «musica dell’avvenire».
Molte opere di Wagner prima del Parsifal, «la torre che supera in alto, nelle nuvole, tutto l’edificio dei Nibelunghi» (come scrive Wagner a Luigi III nel 1874) segnalano la loro partecipazione ai mitemi orfici! Ne sono testimonianza l’ossessione dell’iniziazione sin dal 1850 in Lohengrin; ma anche la problematica del ritorno e dei suoi pericoli (il «peccato di Orfeo» che articola le sue passioni) nell’interdetto fatto a Elsa (sorta di Euridice al contrario) di interrogare Lohengrin sulle sue origini, la cui trasgressione porterà il cavaliere al «ritorno» definitivo verso il Graal.
Tali nostoi sono ripetuti da Tannhaüser nel suo desiderio di ritornare al mondo dei mortali (I atto), nel suo canto scandaloso del II atto che è un «ritorno a Venere», nel ritorno pietoso del pellegrinaggio, nel breve e disperato ritorno al Venusberg del III atto, nel ritorno finale e breve a Elisabetta portata via dalla morte come Euridice…
Il Tristano, infine, non è che una immensa «nostalgia». Il ritorno in Cornovaglia del I atto, il brutale e banale ritorno del re Marco e di Melot che sorprendono gli amanti nel II atto, il ritorno del morente a Karéol, l’ultimo e straziante ritorno di Isolda e ancora l’amato rapito dalla morte. La reminiscenza diviene un processo drammatico costante in Wagner nei grandi racconti che sono splendidi recitativi che costellano la Tetralogia.
L’utilizzazione sistematica del leitmotiv musicale in Wagner rinforza i poteri originari del «ritorno» della musica. Il leitmotiv aggiunge uno spazio sonoro identificatore agli elementi della reminiscenza del racconto. Lenta mutua reminiscenza dei due Wälsungen nel I atto della Walkiria, sottolineata dai leitmotivedel Walhalla, dei Wälsungen, della Spada. Magnifico e doloroso racconto reminiscente di Wotan nel II atto. Grottesche reminiscenze dell’infanzia di Sigfried rivelate da mimo nel I atto del Siegfried illustrate genialmente dai leitmotive dei Wälsungen, dell’Amore. Nel II atto il sangue del dragone vinto permette a Siegfried di comprendere il racconto reminiscente dell’uccello.
L’apogeo di queste drammatiche reminiscenze sarà raggiunto nel Crepuscolo con l’oblio, il «non ritorno», per così dire, grazie al filtro fatale che scatenerà l’orribile dramma: l’abbandono, la consegna di Brunilde a Günter. È improvvisamente la reminiscenza che trascina Siegfried, poi Brunilde, nella morte felice ed infine è il ritorno dell’anello alle Figlie del Reno.
Tutta questa così vasta opera è votata, fino al Parsifal, alla «passione» dell’eroe – o dell’eroina – alla sua immolazione: immolazione di Senta alla fine del Vascello fantasma, passione dolorosa di Tannhaüser e morte di Elisabetta, strazio dell’amore di Lohengrin e definitiva partenza e morte di Elsa, lenta agonia di Tristano nel III atto e morte di Isolda, infine nell’immensa Tetralogia tutto è «passione»: quella mortale di Siegmound e Siegelinde, quella doppia di Brunilde addormentata nel cerchio di fuoco, tradita, e che infine si getta sul rogo di Siegfried abbattuto da Hagen, infine quella gigantesca di Wotan, Pastor et agnus esemplare, nella lunga Götterdämmerung.
Aggiungiamo ancora a beneficio dell’orfismo wagneriano il posto che il compositore poeta dà alla personificazione della musica, posto che supera di molto i tradizionali Schauspieldirecktor del XVIII secolo. Due delle sue opere, Tannhaüser e i Maestri Cantori si fondano esplicitamente sugli orphéons di Minnesänger o di Meistersinger. In questi due casi la ricompensa suprema del canto è la mano della giovane bellezza, cioè della principessa. Come già in Gluck, il senso viene dato proprio dallo stretto legame tra il senso del poema e la musica, proprio come nella tradizione luterana l’arte corale permette l’autenticità in cui si sposano innovazione creatrice e rispetto delle tradizioni.
Si potrebbe obiettare che stiamo vedendo Orfeo ovunque! Ma proprio Richard Wagner traccia nelle sue opere e nei drammi lirici i grandi tratti della statura di Orfeo, anche se in maniera discontinua, e tutti questi grandi mitemi si riuniscono infine nell’opera suprema, Parsifal.
Secondo P. F. Kæmpf, Parsifal sarebbe soltanto un «mito letterario» – cosa smentita del resto dai lavori di Jean Marx, di Pierre Gallais o di P. G. Sansonetti, interessati alle radici extra-letterarie dei racconti del Graal – mentre il mito realmente mitologico che lo sostiene sembra essere quello di Orfeo.
Ho rintracciato sei mitemi dello scenario iniziatico del Parsifal: 1) sodalità depositaria della tradizione; 2) cerca e prove di apprendistato; 3) prove pericolose; 4) innalzamento orfico attraverso la musica; 5) doni taumaturgici del maestro; 6) trasformazione totale, conversione.

(I sec. d.C.), rilievo
Napoli – Museo Archeologico Nazionale
Questi mitemi possono essere ricentrati più precisamente sotto i quattro mitemi direttori del mito di Orfeo: 1) esaltazione della musica corale; 2) appartenenza iniziatica; 3) passione dell’eroe Pastor et Agnus; 4) conclusione attraverso i nostoi, i «ritorni».
L’appartenenza iniziatica è indubbia: il Parsifal è esplicitante un «mistero» – come si diceva nel medio Evo – di iniziazione, si sviluppa in un ambiente di iniziati, caduti ma redenti dal giovane «folle e puro» e ricorda lo scenario del romantico Zacharias Werner in cui si vedono i «Figli della Valle» redimere e salvare i Templari colpevoli.
Wagner è molto documentato sull’iniziazione e anche se non è stato egli stesso un massone iniziato ha frequentato i suoi amici franco-massoni e certamente Franz List, suo suocero e suo protettore.
Parsifal risponde perfettamente a questo programma, precisamente per il ritorno delle masse corali che la Tetralogia (salvo l’ultima giornata, il Crepuscolo) e anche Tristano (in cui i cori di cavalieri, marinai, soldati sono puramente aneddotici) avevano eluso.
L’orphéon come appariva nelle «opere romantiche» del maestro è qui restituito con un’ampiezza e uno splendore incomparabili: lungo corale che conclude il I atto con delle misteriose e speranzose promesse; il II atto si articola intorno al coro e alle prove delle «fanciulle-fiori», poi «mezzogiorno, ecco l’ora!»; nel III atto abbiamo l’immenso coro dei cavalieri che circonda l’iniziato e lo consacra «redentore» con le ultime e misteriose parole: «Redenzione al redentore».
Su questo oceano corale, su questa saga iniziatica si articolano gli altri due mitemi.
Dapprima la «passione» dell’eroe che si amplifica dal I atto, in cui si limita al rimprovero di Gurnemanz per l’uccisione del cigno, all’annuncio da parte di Kundry della morte della madre e infine all’espulsione da parte di Gurnemanz che lo tratta da folle (Tor) e allo stesso tempo da papero (Gänzer).
Il II atto è il grande atto della prova, tentazione assai superficiale inizialmente, da parte delle «fanciulle-fiori» poi improvvisamente tentazione da parte dell’«arcidiavolessa, la rosa infernale» Kundry che accusa, con prove, il giovane di aver ucciso di dolore sua madre e infine gli dà il terribile bacio materno che ha già ferito a morte il re del Graal Amfortas. Parsifal resiste e alla perversa tentazione succede la santa collera; da vittima – agnus – diviene colui che domina la colpevole passione di Kundry e si impadronisce della lancia fatale lanciatagli da Klingsor.
Il tema della nostalgia di Orfeo si rivela soprattutto nelle amplificazioni parsifaliane dei ritorni, dei rivolgimenti, delle reminiscenze e delle conversioni. Abbiamo la reminiscenza dei «racconti d’infanzia» o del passato nel I atto in cui Gurnemanz «spiega» ai giovani scudieri la cause del malessere riversatosi sul «magagnato» Amfortas e in cui l’uccisore del cigno racconta per sommi tratti il suo errare; nel II atto le brevi reminiscenze di Klingsor e la terribile reminiscenza provocata da Kundry dell’errore matricida di parsifal; nel III atto, l’atto del ritorno benedetto e definitivo, si trovano ancora i ricordi di Gurnemanz, di parsifal penitente, l’ultimo racconto della morte di Titurel.
Ma il vero sigillo dell’iniziazione sono i rivolgimenti e i ritorni materiali: l’esplicita inversione della procedura di cambiamento di scenario nelle indicazioni stesse di Wagner «nel III atto, trasformazione progressiva dello scenario, come nel I atto, ma questa volta da destra a sinistra… nur von rechts nach links».
Nel Parsifal molte altre inversioni, inesplicabili senza il ricorso al simbolo della «visione allo specchio», dovrebbero attirare la nostra attenzione.
Per esempio nel II atto Kundry, la donna peccatrice, sostituto della madre terribile opera un insolito «rivolgimento» sia del nome che degli attributi di colui che il nobile padre Gamurel chiamava Parsifal e lo chiama «Fal-Parsi» «törger Reiner» invece di Parsifal der reine tor. Altro esempio: l’inesplicabile armatura nera dell’eroe al III Atto – mentre il reame del Graal e di Lohengrin è bianco come il cigno – si chiarisce, se si conosce la leggenda che vuole che il cigno bianco sia nero all’interno. Il nero è segno di interiorizzazione del bianco cigno dal 1850! Nella mistica musulmana, il nero luminoso è l’emblema del sesto profeta: Gesù.
C’è un altro ritorno più grande, sul quale non si è mai abbastanza insistito. Il giorno più cupo, il Venerdì Santo, giorno della morte di Dio, della sua assenza nei tabernacoli delle chiese cattoliche, del velo funebre delle immagini sante, in cui si celebra l’officio più disperato della liturgia cristiana, diviene il famoso «Incantesimo del Venerdì Santo» di cui Parsifal stesso si meraviglia. «Sciagura, o giorno di suprema sofferenza… tutto ciò che sospira, vive e nasce dovrebbe gemere e piangere… Was atmet, lebt und wieder lebt, nur trauern, ach! und weinen!» è capovolto nell’ingenua risposta di Gurnemanz: «Vedi, non è così… sono le lacrime dei peccatori pentiti che sono divenuti rugiada». Il cavaliere comprende e amplifica questo messaggio, estende questa «redenzione» alle fanciulle-fiori peccatrici e dà il bacio di pace a Kundry. Segue allora una grandiosa conclusione con Parsifal, vestito da Cavaliere, armato della lancia, che avanza nelle tenebre del doppio lutto del palazzo del Graal: la spoliazione di Titurel e la disperazione del «magagnato» Amfortas.
Il musicologo Jean de Solliers sottolinea come il «pessimismo assoluto» espresso dagli accordi in sol maggiore/mi minore, il coro all’unisono (vecchia reminiscenza massonica del corale figurato del flauto incantato che fa eco al massonico richiamo di Gurnemanz: «Mezzogiorno, l’ora è arrivata»), il terribile rintocco delle campane, siano improvvisamente illuminati e capovolti dallo scintillio delle arpe, dallo splendore raggiante dei temi religiosi questa volta in tono maggiore. Solliers ritiene questa musica ciò che «di più bello, di più intenso, di più carico di sensibilità » abbia scritto il maestro di Bayreuth il quale esigeva che Parsifal, essendo un Bühnenweih-festspiel (sacra rappresentazione) non fosse rappresentato che al Festspielhaus di Bayreuth, perché per Wagner «l’opera d’arte è la rapresentazione vivente della religione […]; il prete dell’arte, diceva Wagner, è il solo che non ha mai mentito. La musica di Parsifal è vera. Essa non è solamente consolatrice, è uno strumento di conoscenza più alta, e per ciò stesso di liberazione…».
Forse in queste ultime scene del dramma di Wagner in cui le tenebre del Venerdì Santo, la mala-morte che minaccia Amfortas sono improvvisamente sovvertite, redente, si può chiarire ciò che spesso nell’opera può sembrare un tradimento del mito. Già Monteverdi, non tenendo conto della fedeltà del suo librettista Striggio alla fine funesta del mito di Orfeo, aveva finito l’opera con una gioiosa apoteosi su un’aria di moresca. Anche Gluck sarà poco fedele alle conclusioni del mito: Euridice, alla fine dell’Orfeo è resa per amore al suo sposo… Questa ripetuta infedeltà alle conclusioni letterali delle lezioni del mito e che si impone a tutte le sue trascrizioni operistiche, non è forse fedeltà suprema al significato profondo del mito? Chi oserebbe affermare che l’Orfeo-cristico è morto? O che il figlio di Zeus, Dioniso, non è stato portato in cielo dove del resto egli ha portato Arianna? Ricordiamoci dell’analisi mitemica che ci mostra, nel quarto gruppo di racconti (la Tomba di Orfeo), come Orfeo nell’aldilà non subisca più prove. La testa suppliziata di Orfeo canta ancora, non fa che cantare, riposando per sempre sulla lira.
Il senso ultimo dell’ultima parola del Parsifal, «Redenzione al redentore», significa dunque che questi «capovolgimenti», queste nostalgie redimono il tormento dell’eroe e gli impongono la Redenzione, l’annullamento e-statico delle peripezie e delle pene di questo basso mondo.
Il vero Orfeo, in quanto tale, è questo maestro, questo pastor glorioso che continua a vivere proprio in quanto fu vittima, agnus. Del resto uno dei grandi orfici, Jean Cocteau, non diceva forse che il «poeta non muore mai, fa finta!».
La ragione suprema di tante versioni di Orfeo non è forse proprio questa infedeltà al destino comune che fa sì che il canto continui senza sosta una volta che il sipario è banalmente caduto? «Anti-destino» diceva Malraux di ogni arte. Se gli eroi dei romanz sono immortali, quanto ancora più facile l’immortalità per l’eroe dell’opera, incarnato nell’immortalità ridondante della musica!
La suprema lezione del mito di Orfeo non è forse proprio quella testa separata dal corpo che, insieme alla lira, canta per l’eternità ?
BIBLIOGRAFIA
Menzioniamo, soltanto per darne memoria, le apparizioni di Orfeo nell’opera di Virgilio, Ovidio, Apollonio di Rodi, Diodoro Siculo, Strabone, Pausania, Arako, Conone, Apollodoro, Simonide, Pindaro, Eratostene, Eschilo.
R. Aigrin, Liturgia. Encyclopédie populaire des Connaissances Liturgiques, Bloud et Gay, Paris 1935; id. La musique religieuse, Bloud et Gay, Paris 1929.
P. Brunel, “Orphée” in Dictionnaire des Mythes Litteraires, Ed. du Rocher 1988.
M. Cazenave, Encyclopédie des symboles, Livre de Poche, 1966.
J. Canteins, Mystères et symboles Christiques, Ed. du Rocher, 1996.
J. Chailley, Parsifal opéra initiatique, Buchet-Chastel, Paris 1979.
H. Corbin, En Islam Iranien, 4 Vol., Gallimard 1972.
G. Durand, “Vagner et les mythèmes décadents” in Essai sur l’imaginaire musical, Direction S. Vierne, Un. Stendhal 1984; id., “Le retour des Immortels” in Le Temps de la Reflexion III, Gallimard 1982; id. “L’initiation dans l’oeuvre de Wagner” in Voyage imaginaire voyage initiatique, CRVI, Verona 1990; id., Beaux Arts et Archétypes, la religion de l’art, PUF, 1989.
P. Gallais, Perceval et l’initiation, Ed. Sirac, Paris 1972.
B. Juden, Traditions Orphiques et tendances Mystiques dans le Romantisme français, Klincksieck 1971.
P. F. Kaempf, “Parsifal” in P. Brunel, Dictionnaire des mythes littéraires oc.
Eva Kushner, Le mythe d’Orphée dans la littérature française contemporaine, Nizet, Paris 1961.
M. Maffesoli, L’ombre de Dyonysos, Meridiens, Paris 1952.
J. Marx, La Legende arthurienne et le Graal, Puf, Paris 1952.
“Parsifal” da Avant Scène Opéra, n 38-39, Gennaio 1982 (articoli di Cl. Lévi-Strauss, A. Tubeuf, Ph. Godefroy.
J. Pothier, Paléographie musicale, Solesme, Ttournon, 1889-1911.
L. Reau, Iconographie de l’art chretien, T. II, 3. p. 33 e ss. PUF 1937.
S. Reinach, Cultes, mythes et religions, t. II, Lerouy 1928; id., “La mort d’Orphée”, Révue Archéologique, 1902 II.
A. Siganos, Le minotaure et son mythe, PUF 1993.
P. G. Sansonetti, Graal et Alchimie, Berg, Paris 1982.
D. P. Walker, La magie spirituelle et angelique.
De Ficin à Campanella, trad. franc. A. Michel, 1988.