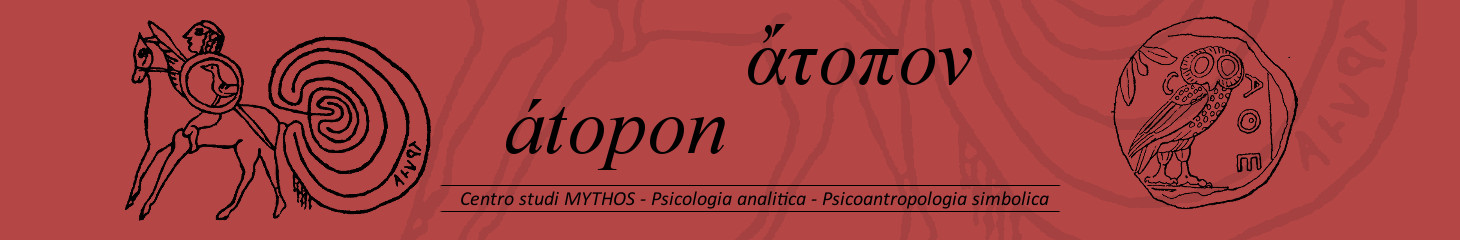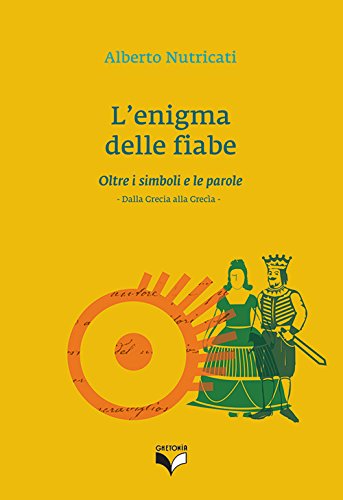L’arte del narrare ha avuto in passato un ruolo fondamentale nella vita culturale delle comunità in tutte le culture ed ancora oggi lo conserva nelle culture tradizionali sopravvissute ad un rapido processo di conversione tecnologica.
In tempi antichi, non dominati dai miti dell’efficienza e della produttività propri della cultura tecnologica, ogni popolo conosceva una pluralità di linguaggi di grande spessore semantico e usava differenti modalità espressive a seconda del luogo, del tempo, della situazione o a seconda del referente della comunicazione o dell’argomento che doveva esserne l’oggetto.
Ogni situazione, ogni contesto, ogni argomento richiedeva uno stile, un vocabolario, una modalità di espressione, una intonazione particolare della voce, un timbro di voce particolare.
L’arte della retorica (cioè l’arte del dire) era considerata fino a qualche decennio fa, anche nella nostra cultura, erede della cultura classica, nel novero delle arti liberali e indispensabile bagaglio di ogni uomo colto.

In Grecia il narratore, l’aedo, era figura particolarmente venerata ed a lui era affidata la memoria del popolo, della sua storia, dei suoi valori, della sua tradizione, della sua areté (= valore). Per i Greci l’areté (che i latini chiamavano virtus, cioè la dote propria di un uomo) consisteva infatti nella capacità dell’uomo di vincere la battaglia con se stesso, con il male, con l’errore, con i nemici e doveva portare alla kalokagathia, (realizzazione ad un tempo del bene e della bellezza).
L’aedo era anche considerato “vate”, perché chi sa ricordare e narrare gli eventi del passato sa vedere anche nel futuro. Omero era il vate per eccellenza e, secondo la tradizione, era raffigurato cieco: i suoi occhi non si soffermavano sulle cose del mondo circostante ma miravano alle vicende mitiche collocate nell’eterno presente. Un ricordo di questa antica, sacra arte del narrare permane ancora oggi, con tutto il suo incanto e la sua sacralità, nella narrazione di un mito (dal greco mythos= parola) o di una favola.
Ogni situazione narrativa è un’espressione d’arte in quanto è un unicum irripetibile e può essere considerata un momento di contatto con il sacro in quanto il tempo profano (etimologicamente: fuori dal recinto del tempio), delle normali preoccupazioni della vita è temporaneamente interrotto.
Narrare una fiaba vuol dire entrare in un ambito comunicativo completamente diverso da quello della vita quotidiana.
Si crea una atmosfera particolare. L’ascoltatore è trasportato nel tempo e nel luogo del mito: al “tempo in cui Berta filava”, al tempo del “c’era una volta”, che è il tempo dell’eterno presente e nel luogo meraviglioso e segreto a cui l’uomo sempre aspira come a lui destinato.
Tra colui che narra e gli ascoltatori si stabilisce un’interazione che viene evidenziata anche spazialmente: gli ascoltatori si pongono intorno al narratore in cerchio (il cerchio magico che è anche un temenos) eliminando così ogni elemento di dispersione e concentrando l’attenzione sulla voce portatrice di un messaggio che viene da lontano, da un luogo senza luogo, potremmo dire da un átopon.
La fiaba e il mito hanno particolare importanza in quelle culture in cui è particolarmente viva la tradizione orale come ad esempio presso i pellerossa, gli eschimesi polari, gli aborigeni australiani e in molte etnie africane ove il narratore è sempre figura di grande prestigio.
Presso i Meru dell’Africa meridionale, per citare solo un esempio, il narratore, chiamato mugambi (il possessore della parola) possiede doti particolari. Non solo è considerato un raffinato dicitore e conoscitore dell’arte della comunicazione ma anche un uomo saggio, dotato di grande forza morale e di carattere, capace di amministrare la giustizia e di presiedere una assemblea conducendola a felice conclusione.
La letteratura orale è inoltre un campo privilegiato di manifestazione della cultura. Come ci segnalano gli studiosi di etnolinguistica, in essa si incontrano inscindibilmente connessi molteplici procedimenti stilistici e numerosi elementi contestuali che hanno tutti un ampio profilo semantico e un denso significato simbolico.
Il messaggio affidato al testo diventa vivo grazie alla voce del narratore che riesce ad animarlo attraverso intonazioni, gesti, timbro, tono della voce; il narratore stesso assume una alta funzione pedagogica quale trasmettitore dei valori tradizionali della cultura. Il contesto ci porta la visione del mondo propria della cultura a cui appartiene la narrazione, mentre la lingua in cui il testo è trasmesso, generalmente diversa e più preziosa di quella usata nella vita quotidiana, ne sottolinea la sacralità.