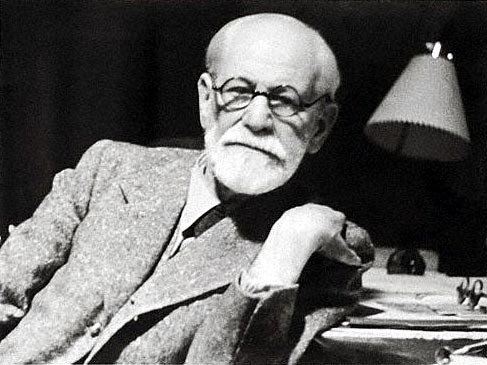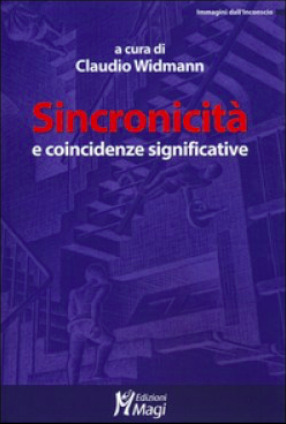Comunicazione tenuta al II Convegno Internazionale di Psicoantropologia Simbolica e Tradizioni Religiose, Palazzo Baldassini, Roma 24 Aprile 1993
Sulle modalità psicologiche del processo creativo, Jung si intrattiene in modo significativo nel paragrafo dei Tipi psicologici che parla della relatività del simbolo, prendendo spunto da Eckhart 1.

Egli dapprima spiega che per relatività di Dio intende che Dio non è un assoluto metafisico staccato dal soggetto umano, ma che anzi va visto come, in un certo senso, dipendente dall’uomo, “cosicché da un lato l’uomo può essere inteso come una funzione di Dio e dall’altro Dio come una funzione dell’uomo”2.
Quando un simbolo siffatto viene riconosciuto per ciò che realmente è, cioè per qualcosa che appartiene all’anima, allora esso può agire come un complesso autonomo di grande forza. Questo in particolare è il frutto della conversione: l’oggetto esterno perde valore, la libido viene disinvestita e riportata sul soggetto, così da riconoscere che il ‘Regno di Dio’ è dentro di noi e non più fuori. «Chi ha questo valore in sé – dice Jung – è di buon animo dovunque; egli non dipende dagli oggetti, cioè non ha bisogno di nulla e non attende dall’oggetto ciò che gli manca»3.
Questa abbondanza di libido introiettata determina uno stato di benessere che Jung paragona alla beatitudine di cui parla Eckhart quando dice che Dio è beato nell’anima. Si può anche restare sconcertati dal semplicismo con cui Jung a volte interpreta le espressioni di Eckhart, che sembrano alludere a livelli di esperienze assai più elevate, ma è anche vero che proprio per questo egli riesce a raggiungere una grande efficacia, che forse mancherebbe a interpretazioni più, diciamo così, ‘metafisiche’. Comunque sia, Jung si pone il problema di capire donde venga all’anima questa beatitudine o voluttà, che egli paragona allo stato di Brahman dell’induismo, e deduce che essa venga sostanzialmente dall’inconscio, mentre l’Io è quasi scomparso, a somiglianza di quanto avviene nei bambini o nei primitivi.
Questa è una prima acquisizione importante, sulla quale dovremo tornare, che lo stato di pienezza comporta la quasi scomparsa dell’Io. Lo stato mistico dell’infanzia corrisponde a un momento in cui l’energia interiore fluisce liberamente, senza incontrare resistenze, senza sforzo da parte del soggetto, dando una gioia che “sgorga calda dall’interno”, mentre sembra che le cose vadano da sé. Solo che nel bambino questo stato è destinato a finire mano a mano che, diventando adulto, l’energia che fluisce dal suo interno finisce con l’investire gli oggetti, che così acquistano progressivamente importanza a detrimento dell’interiorità.
Nel mistico invece avviene il contrario, perché egli, mediante il sacrificio, ritira continuamente la libido dagli oggetti in nome di un ideale interiore. In altri termini, la libido a sua disposizione non si esaurisce mai perché egli se ne riappropria continuamente, ritirandola dagli oggetti. Si crea così come un tesoro interiore che, secondo l’interpretazione che Jung dà di Eckhart, sarebbe il Regno di Dio nascosto in quel campo che è l’anima.
Per Jung le corrispondenze sono chiare, direi, ancora una volta, quasi semplicistiche: “l’anima è la personificazione dell’inconscio, il tesoro è la libido calata o inabissatasi con l’introversione”, il Regno di Dio “significa uno stabile accordo o un’unione con Dio, uno stato nel quale una preponderante somma di libido4 risiede nell’inconscio e di là determina la vita cosciente”
In realtà però non tutto va sempre così liscio, come Jung sembra cogliere nelle parole di Eckhart, secondo le quali «è una condizione più alta che Dio sia nell’anima che non che essa sia in Dio; per il fatto di essere in Dio, essa non è ancora beata, mentre lo è per il fatto che Dio èin essa».
Se l’anima è in Dio, ciò significa due cose :
a) o che essa è sprofondata nell’inconscio, che si è perduta in esso e che quindi non può agire da mediatrice5;
b) o che la libido è ancora dispersa negli oggetti (v. sopra). è uno stato di sofferenza.
Se invece Dio è nell’anima, ciò significa che essa lo percepisce al suo interno, lo sente nascere in sé (sempre Eckhart), e allora può far da mediatrice tra inconscio e coscienza, attraverso la sua capacità di creare immagini (è essa stessa un’immagine). Attraverso le immagini i contenuti inconsci diventano accessibili alla coscienza. Questo, a differenza dell’altro, è uno stato felice e lo stato di felicità è uno stato creativo6.
Esso condurrebbe, secondo le approssimazioni di Jung, in quattro direzioni:
1) la creazione artistica,
2) la creazione filosofica (e a queste prime due Jung attribuisce uno statuto speciale),
3) una creazione di carattere “quasi religioso”, che condurrebbe alla formazione di eresie o sétte (Jung evidentemente decide di ignorare ogni aspetto interiore della creatività religiosa. Delle sétte in particolare mette in risalto il carattere astinente, ascetico),
4) una creatività che si degrada in dissolutezze di tipo gnostico (e anche qui il giudizio sul cosiddetto anomismo delle sette gnostiche sembra piuttosto sommario)7.
È evidente che Jung ha una scarsa considerazione delle due ultime manifestazioni della forza creatrice e molta invece delle prime due. è lecito qui inferire una sua scarsa conoscenza dell’importanza dell’intuizione nell’esperienza mistica e un privilegiare invece, in campo religioso, la capacità speculativa, una tendenza che, se in parte sarà corretta in seguito, resterà pur sempre una caratteristica del pensiero di Jung nei confronti dell’esperienza religiosa suprema.
Ma come lavorare in concreto con questi contenuti inconsci o meglio ancora, come dar forma reale alla tensione creatrice che emerge attraverso le immagini? Due metodi sono possibili secondo Jung, il riduttivo e il sintetico, che, è bene sottolineare vigorosamente contro l’opinione comune, egli vede integrabili l’uno con l’altro e niente affatto in contrasto8. Il primo riconduce tutto agli istinti di base e quindi alla realtà, alla sopravvalutazione di essa, e poi al necessario sacrificio e all’introversione della libido; il secondo lavora sulle “fantasie simboliche” che emergono nella fase di introversione, creando un nuovo rapporto con la realtà. Questa fase creatrice è frutto della funzione trascendente.
Il processo alterno di estroversione e introversione è paragonato da Jung al processo cosmico di sistole e diastole intravvisto da Goethe. Sarebbe anche lecito richiamare le fasi del respiro e la modalità altamente simbolica secondo la quale esse sono state interpretate in tante tradizioni religiose.
Tralasciando la più conosciuta, che è l’induismo, si potrebbe accennare che anche alla mistica cristiana essa è nota, per esempio nelle aspirazioni con cui il mistico inglese Augustine Baker designa il più alto grado della preghiera mistica9. L’aspirazione è analoga al processo di ritiro della libido, di sacrificio, di disinvestimento oggettuale; mentre l’espirazione è il momento in cui la libido, pervenuta a un livello superiore al precedente (nell’elaborazione interiore dovuta alla funzione trascendente), fluisce di nuovo verso il mondo ricreandolo, cioè stabilendo con l’oggetto un rapporto completamente nuovo e fecondo di ulteriori sviluppi. Si passerà poi ad una nuova fase di aspirazione ed espirazione. Sarebbe troppo ovvio ricordare come la parola “ispirazione” (in-spirazione) faccia normalmente parte del vocabolario della creatività.
Procedendo nel suo commento a Eckhart, Jung osserva che c’è un punto dell’esperienza mistica in cui è necessario che l’anima si perda in Dio, ma pur rendendosi conto delle analogie con l’Oriente, e quindi dell’universalità di tale concezione, non sembra prendere posizione chiara a favore di questo stato, che del resto, in modo superficiale, paragona alla participation mystique dei primitivi.
Possiamo pensare che, in quanto psicologo, egli vedesse con una certa diffidenza tutte le forme di depotenziamento o addirittura di dissolvimento dell’Io e del resto questo stato sembra rassomigliare un po’ troppo a quello dell’ “anima in Dio” che aveva appena definito come negativo.
Ma quando si tratta di mistica Jung, si sa, fa come un salto indietro. Se infatti egli avesse spinto più oltre la sua esegesi di Eckhart, si sarebbe accorto che le immagini hanno ben poco o, addirittura, nessun valore e anzi, dal punto di vista di quel filone della mistica detto apofatico, cui Eckhart appartiene, esse, non che rappresentare un tramite essenziale tra inconscio e coscienza, sono considerate come un ostacolo da eliminare.
Il vuoto di immagini, il silenzio, l’assenza, l’oscurità si sostituiscono al mondo delle immagini, che è il mondo psichico. Questo silenzio sembra far parte di un altro mondo, che è solito esser designato, nella letteratura spirituale dell’Occidente, in vari modi, come spirito, fondo dell’anima, cima sottile o punta dell’anima (o dello spirito), porzione verginale, apex mentis, ecc. A questo fondo l’Io non può accedere se non negandosi e anzi morendo a se stesso. Il medesimo Jung ha ben presente questo quando, come espressione di un Sé realizzato, indica la frase paolina: «Non sono più Io che vivo ma è Cristo che vive in me»10. Gli esempi, a parte S. Paolo, potrebbero moltiplicarsi, per cui mi limiterò a sceglierne solo due, presi uno dal terzo secolo, un momento di sutura tra mondo antico e mondo cristiano, e il secondo dall’epoca nostra. Nel primo caso si tratta di Plotino, nel secondo di Simone Weil.
In Plotino la morte è il momento di ritorno all’unità, ma, si può dire, il “ritorno” (epistrophé) in assoluto è momento essenziale delle aspirazioni dell’anima, cui essa può pervenire anche con un atto supremo di intuizione contemplativa, prima quindi della morte fisica, cioè raggiungendo uno stato di libertà assoluta dello spirito, paragonabile solo alla morte.
“Chiunque abbia contemplato, sa ciò che io dico: che l’anima, sia perché si è elevata sino all’Uno, sia perché è già vicina e partecipe di Lui, possiede una vita nuova; e perciò, in tale disposizione, sa ormai che il largitore della vita è lì presente e che non le occorre più nulla.
Noi pertanto dobbiamo deporre ogni altra cosa e attenerci a Lui solo; dobbiamo anzi trasformarci in Lui liberandoci di ogni aggiunta, a tal punto che bramiamo di uscire dal mondo e non sopportiamo più di essere ancora legati al sensibile, poiché vorremmo abbracciare Dio con tutto l’essere nostro e non avere più alcun punto che non sia in contatto con Dio”11.
Ma la cosa più interessante è che da sempre, secondo Plotino, esiste un’unità dell’anima con l’Uno e che l’unico problema è di saper riconoscere questo fatto e spogliarsi del superfluo, di ciò che in altri termini finisce con l’inquinare o dissimulare l’Unità. Questo elemento inquinante appare proprio come Io, il quale, nella sua ansia di autoaffermazione non si accorge di allontanarsi sempre più dall’Uno.
«Tu sei già arrivato nel Tutto ma lasci da parte questa grandezza per diventare ‘tutto’. Eppure eri ‘tutto’ anche prima; ma poiché ti sei aggiunto qualche cosa d’altro oltre il tutto, tu, proprio per questa aggiunta, sei diventato piccolo, poiché l’aggiunta non veniva dal Tutto – al quale non si può aggiungere nulla! – bensì dal non-tutto.
Ma se uno s’è fatto qualcuno per mezzo del non-essere, egli è non-tutto, e sarà Tutto quando avrà eliminato il non-essere»12.
A distanza di molti secoli una mistica contemporanea, Simone Weil, arriva alle stesse conclusioni mediante il proprio concetto di “decreazione”. Come Dio per creare il mondo (secondo una concezione che si ritrova p. es. nella cabala ebraica), deve ritirarsi in se stesso, anche l’uomo spirituale deve ritrarsi da sé o meglio dalla propria egoità (decrearsi): «L’Io non è altro che l’ombra proiettata dal peccato e dall’errore che arrestano la luce di Dio e che io scambio per un essere»13.
Per Simone Weil esiste una parte dell’anima creata da Dio, che è perfetta e inalterabile, e una parte creata dall’uomo, che può essere intesa come Io. è quest’ultima che deve essere decreata.
«C’è in noi qualcosa che bisogna chiamare divino e che ci pone già vicino a Dio: è il moto di trarsi da parte, l’abbandono è l’abbandono di ciò che crediamo di essere, ritiro al di fuori di noi e al di fuori di tutto… perché Simone Weil è fermamente convinta che – questa abdicazione, questo amoroso acconsentire a non essere nulla, questo slancio immoto del desiderio verso una morte anticipata, sia l’assoluto stesso,… il nostro tratto comune con Dio e la nostra eguaglianza con lui già in questo mondo»14.
«Ciò che nell’uomo è immagine di Dio non è il fatto che egli sia una persona; ma qualcosa che è connesso con questo: è la facoltà di rinunciare a essere persona, è l’obbedienza»15.
È solo attraverso l’annullamento di sé che la creatura può assimilarsi a Dio ed uscire così dal dolore dell’esistenza separata.
Una felice metafora della Weil, che ricorda in qualche modo Plotino, è quella secondo la quale l’Io dell’uomo sarebbe assimilabile a un numero negativo, che più si accresce nella scala numerica, più in realtà si riduce, e solo diventando zero raggiunge invece il valore massimo. Dunque la morte dell’Io, la “decreazione”, è essa stessa in realtà autocreazione, nel senso più vero, perché spirituale, del termine. L’altra manifestazione concreta della “decreazione”come autocreazione si ha nel grado più alto della preghiera mistica, cioè nella contemplazione.
Secondo la letteratura mistica universale, esiste un tipo di presa di contatto con l’interiorità che si fonda proprio sul silenzio, sulla quiete e sul riposo interiore, senza alcuna riflessione volontaria del pensiero, senza filtri simbolici o immaginali, senza interpretazioni date dalla coscienza; un campo, come è facile comprendere, quasi del tutto estraneo alla visione di Jung, ma ciò non di meno di importanza fondamentale per il nostro argomento.
Si tratta, nella pratica, di una specie di attenzione virtuale e abituale al fine ultimo, “più che un tendere diretto e formale verso di esso”16, un’attenzione fondata sulla sicurezza che è fiducia nella presenza reale di questo fine.
In tale stato, l’anima guarderà alla meta priva di immagine con un’attenzione silenziosa, vuota tanto di parole che di pensieri, «in un dolce e tacito consenso amoroso della volontà, che permette allo Spirito di prendere interamente possesso dell’anima come di un tempio che gli appartiene ed è consacrato a lui, e in cui egli è presente… »17.
La pratica del silenzio sopra descritta è raccomandata dal Baker e da altri mistici come pratica quotidiana, che alle persone pià esercitate viene consigliata nella misura di due momenti al giorno di circa un’ora ciascuno. è la preghiera della pura Presenza. Se nel silenzio si manifestano affetti, l’anima li segue pacificamente fin tanto che durano e poi torna al silenzio. Se prova aridità, oscurità, insensibilità, non interromperà la perseveranza nel silenzio e così con le distrazioni. Non deve aspettarsi nulla. L’esercizio è consigliato anche ai principianti: esso consiste nello stare “aux escoutte”, di guardia, in ascolto, senza immagini, senza interpretazioni18.
Ma a questo punto avviene un fatto determinante, per quanto inatteso, che i mistici occidentali designano con il nome di “notte oscura”, “grande desolazione” e simili. Quando si crede di aver raggiunto risultati ormai solidi e che nulla possa togliere la Presenza di cui si è fruito, arriva l’inatteso sottrarsi di Dio.
Lo stato di angoscia e abbandono è tale, dice sempre il Baker19, che molti impreparati desistono e tornano alla vita ordinaria. è uno stato di pura sofferenza in cui si affonda a poco a poco. L’anima è piena di immagini vane, di distrazioni, come non era più da molto tempo.
Per di più questo è un martirio che può affliggere per mesi, a volte per anni (sia pure con delle interruzioni). Lo stato di desolazione è allora tale che l’uomo ha come la percezione reale del proprio essere nulla, cosicché, potremmo dire, l’opera della propria decreazione ha raggiunto il suo culmine e il suo scopo.
Nella mistica occidentale, questo stato è considerato positivo e ricco di frutti, perché comporta, col sentimento della propria nullità, l’ingresso in uno stato di pura confidenza e abbandono a Dio. Solo in questo fiducioso totale abbandono può consistere lo stato di perfezione (o di completezza, come preferirebbe dire Jung). In esso infatti, dice ancora Baker, il nulla dell’uomo si fonde col nulla di Dio (che si è sottratto alla percezione).
Perciò Simone Weil vede nella croce (morte, assenza) un momento addirittura più alto della stessa resurrezione (ma forse potremmo dire che i due momenti, che la narrazione evangelica presenta in successione, vanno interpretati spiritualmente come due facce di un unico momento: la morte è resurrezione proprio perché è sottrazione ed assenza).
Concludendo, credo che questi pochi cenni alla letteratura mistica siano sufficienti ad allargare opportunamente alcune felici intuizioni di Jung nel senso:
1) che la tensione creatrice mira ad esplicarsi non soltanto nell’arte e nel pensiero, ma anche, e in maniera non meno intensa e valida, nella vita spirituale;
2) che in questo senso si può dire che una parte importante della creatività si manifesta nel processo di individuazione, che perciò può definirsi come autocreazione;
3) che questa autocreazione comporta un depotenziamento dell’Io o un rovesciarsi delle sue aspirazioni, nel senso che da prepotente si fa obbediente (al Sé), da autoaffermativo si fa abnegante, ecc.;
4) che ogni autocreazione riuscita sarà dunque in realtà, secondo la felice espressione di Simone Weil, una “decreazione”.
_____________________
NOTE:
1) Opere, VI, Torino 1969, pp. 245 ss.
2) Ibid., p. 247.
3) Ibid., p. 250.
4) Ibid., p. 254.
5) In Symbole der Wandlung (tr. it. in Opere, V, Torino 1970, pp. 303, 348, 397, 403) appaiono tre possibili fallimenti della introversione: 1) regressione psicotica, 2) regressione alla madre personale, 3) rifiuto della regressione con attaccamento agli pseudo-valori della persona.
6) Tipi, cit., p. 255.
7) Mi sono occupato del libertinismo gnostico, da un punto di vista prevalentemente junghiano, in Simboli di trasformazione cabalistici ed alchemici nell’Es mesaref, con un excursus sul libertinismo gnostico, in «Annali dell’Istituto Orientale di Napoli», 41 (1981), pp. 41-81.
8) Tipi, cit., p. 256.
9) Holy Wisdom, tr. it. La Santa Sapienza, 3 voll., Siena 1984, III, p. 218. ss.
10) Prefazione a D. T. Suzuki, An Intoductin to Zen Buddhism, tr. it. in Opere, XI, Torino 1979, p. 556.
11) Enneadi, VI, 9, 9, trad. G. Faggin, Milano 1992, p. 1359, corsivo mio.
12) Ibid., VI, 5, 12, p. 1165, corsivo mio.
13) Cahiers, tr. it., III, Milano 1988, p. 92.
14) M. Blanchot, L’entretien infini, Paris 1969 [p. 153-154], cit. in un importante studio, dedicato proprio a questo problema, di L. Besazza, tesi di laurea inedita, Università di Venezia 1993, p. XX.
15) Attente de Dieu [137], cit. ibid.
16) Così si esprime il già citato Baker, III, p. 194.
17) Ibid.
18) Ibid., p. 202.
19) Ibid., p. 253.