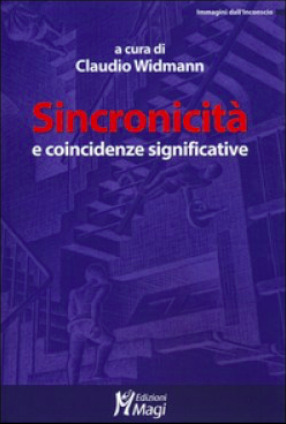Riassunto
La psicologia analitica, nella visione ideale nata dal particolare genio di C. G. Jung, è interpretata come un lungo e faticoso processo di profonda trasformazione che investe l’essere umano nella sua totalità e che ha profonde analogie con l’Opus Alchemicum.

Si tratta di un processo terapeutico (nel senso originario e più pieno del termine), cioè di un cammino iniziatico in cui, come per i tradizionali processi iniziatici, la meta ideale è raggiungere il Sé, “compiere il compimento”, conseguire il ‘telos assoluto”, il termine finale del processo di sviluppo, quel termine che ne esplicita il senso intrinseco.
Proprio l’ultima fase del processo iniziatico, in cui il singolo individuo si propone di raggiungere la visione Suprema, l’epopteia (come è chiamata nei Grandi Misteri Eleusini), è raffigurata simbolicamente nell’Opera al Rosso, o Grande Opera, del procedimento alchemico.
L’opera ermetica sviluppata fino al rosso ha rapporto con la realizzazione del Sé, dell’ homo integer , in cui i conflitti sono superati perché composti in una sintesi superiore, al di là del tempo e dello spazio, nell’átopon , luogo di ciò che è senza luogo.
Lo studio delle molteplici valenze simboliche del colore rosso presso le differenti espressioni culturali e religiose ci aiuta a comprendere il senso di tale fase del processo di trasformazione, ad un tempo materiale e spirituale, proprio dell’alchimia.
* * *
Il problema della sofferenza psichica, della nevrosi, deve essere guardato, secondo la grande intuizione junghiana, come un problema religioso, cioè un problema inerente alla ricerca del senso ultimo della vita.
Il malessere, l’infelicità di cui soffrono molti di coloro che oggi si rivolgono allo psicoanalista forse non è una problematica “di questa terra”, come d’altra parte la felicità cercata non è “di questa terra”. Si tratta forse, per dirlo con Thomas Mann, proprio di quel «principio della protesta, della contraddizione e dell’inquieto peregrinare, il principio che sveglia nel petto di un singolo – mentre gli altri, vicino a lui, vivono lietamente d’accordo, – il germe di un’infelicità che non è di questa terra e che lo spinge a uscire fuori dalla tradizione, dalle convenzioni, nella incertezza avventurosa del nuovo…» (Thomas Mann, Le storie di Giacobbe ). Ma proprio da quella infelicità nasce l’imperioso bisogno di ricerca, la peregrinazione attraverso il tempo e lo spazio la cui meta ultima è quel paradiso terrestre di cui ogni luogo è solo una quinta fittizia.
Come ci insegnano tutte le tradizioni sapienziali e religiose l’uomo deve fare della sua vita un cammino, una cerca; solo così potrà compiere il proprio destino, raggiungere la sua autenticità di uomo. Questo cammino è infatti un tornare a sé stesso, un ritrovare sé stesso. Solo iniziando da se stessi la grande opera di trasformazione, cominciando a percorrere il cammino del ritorno (nostos), del capovolgimento, è possibile anche la trasformazione del mondo.
Quale allora il compito dello psicoterapeuta?
L’archetipo dello psicoterapeuta potrebbe forse essere idealmente ravvisato in quello della guida nel cammino di ricerca, di colui che si propone di accompagnare la psiche (la propria innanzitutto e quella di coloro che chiederanno di percorrere insieme il viaggio) nel viaggio di ritorno ( nostos ) alla patria originaria, attraverso il labirinto della vita. Una guida spirituale, la cui figura, nel senso medioevale del termine, potrebbe essere il principe dell ‘Inno della Perla , degli atti di Tommaso (108-113) il Salvator salvandus /salvatus , il cui compito è di riconquistare la perla caduta in potere del drago e riportarla nel luogo originario da cui era caduta. Tuttavia nel viaggio egli stesso si era perso ed aveva dimenticato il suo compito, sì che deve giungere un messo a ricordargliela.
Dell‘Inno della Perla ci sembra particolarmente importante la profonda idea religiosa che l’uomo mortale sia partecipe della stessa sapienza immortale di Dio, che tuttavia è nascosta prigioniera nel mondo mortale. Dunque ciò che determina l’essenza stessa dell’uomo e di cui egli deve riuscire a prendere piena coscienza per essere salvato e sanato, è proprio la presenza in sé della Sapienza divina come verità.
Il primo compito del viaggio di ricerca è dunque riconoscere la meta, la patria originaria da cui si proviene e a cui bisogna far ritorno, e che è la propria vera natura ontologica (sono « figlio della greve e del cielo stellato» dicevano gli orfici). Solo se si ha ben presente la meta nella sua essenza si può compiere il viaggio senza correre il pericolo di fermarsi alla prima tappa, di rimanere fissati, intrappolati nelle varie situazioni che sembrano offrire una pseudoconsolazione, un falso approdo (come quello indicato dalle sirene che cercano di incantare il navigante Ulisse), ma che sono solo quinte di sabbia che nascondono la meta finale e fanno dimenticare il compito, il telos , il raggiungimento del proprio destino. E’ questa la lezione di tante favole tramandate dalla saggezza popolare e riprese nei versi del poeta: « La mia venuta era testimonianza / di un ordine che in viaggio mi scordai » (Montale).
Se guardiamo al nostro tempo e cerchiamo di procedere ad una analisi dei miti che lo animano e lo muovono, ci sembra che la nostra epoca, ammalata di faustismo e di prometeismo, colpita da un male profondo ed oscuro, disincantata, sia divenuta una Wast land , sterile, assetata e bisognosa di un farmaco salvifico.
Françoise Bonardel nella sua opera dedicata all’alchimia ( Philosophie de l’alchimie, 1993) ci mostra come importanti autori della nostra modernità o postmodernità, filosofi, antropologi, poeti, studiosi delle religioni (cf. Eliade, Corbin, Jung, Bachelard, Guénon, Daumal, Nietzche, Artaud, Heidegger, Rilke) sentendo il bisogno di un radicale cambiamento di prospettive e di una mitologia che potesse ispirare l’uomo contemporaneo dando nuovo slancio alla sua creatività, hanno riscoperto l’antico mito della ricerca alchemica. Si tratta di un mito sostenuto da quella trascendenza dell’immaginare propria di ogni grande arte e che ha creato possenti immagini di ricerca, di trasformazione, di perfezionamento, di integrazione tra materia, anima, spirito. Le tappe di questo viaggio sono rappresentate dalle principali fasi dell’opera di trasformazione alchemica che prendono il nome dai colori che le caratterizzano: nigredo , albedo (Piccola opera) rubedo (o Grande Opera).
Nigredo, opera al nero: calcinazione, distruzione delle differenze, estinzione dei desideri, riduzione allo stato primitivo della materia. Putrefazione che separa gli elementi calcinati fino alla totale dissoluzione.
Albedo , opera al bianco: soluzione, fino alla totale purificazione della materia.
Rubedo, opera al rosso, la Grande Opera: distillazione seguita dalla congiunzione, dall’unione degli opposti (zolfo e mercurio).
Le molteplici valenze simboliche dei colori alchemici, e in particolare del colore rosso, presso le differenti espressioni culturali e religiose amplificano il senso delle fasi del processo di trasformazione, ad un tempo materiale e spirituale, proprio dell’alchimia.
Possiamo confrontare l’ordine alchemico dei colori (nero, bianco e rosso) con quello dei gunas, che rappresentano nella cosmologia indù le tre tendenze principali della sostanza universale ( Prakriti).
Il nero corrisponde alla tendenza simbolicamente discendente (tamas) che si allontana dalla propria origine luminosa; il bianco allo slancio ascendente (sattwa) che si rivolge all’origine, alla Luce; il rosso (il colore del fuoco, del sud, e talvolta della siccità ) alla tendenza espansiva sul piano della manifestazione in se stessa (rajas).
È importante ricordare che gli alchimisti operavano su una sostanza unica, la materia prima. Dovevano trattarla attraverso molteplici triturazioni, lavaggi e distillazioni, separando ciò che è sottile da ciò che è spesso, affinando ciò che è spesso per renderlo sempre più sottile, ma al tempo stesso dovevano cercare di integrare lo spirito, volatile, a parti più dense della materia in maniera da raggiungere progressivamente uno stato di purezza, di omogeneità perfetta, di equilibrio tra gli elementi, come tra i componenti sottili e quelli densi. Il Fuoco, elemento volatile e spirituale, è destinato a prendere corpo mentre la terra, la parte più densa, deve progressivamente divenire spirituale. Lo zolfo rosso, del colore del fuoco, del sangue e dunque della vita e dell’amore, simbolo dell’elemento maschile, del principio originario, della forza attiva e trasmutatrice deve agire sul mercurio elemento femminile ricettivo, passivo e terrestre.
Al termine del processo trasformativo, la materia divenuta infine un composto stabile, di color rosso vivo e di consistenza di cera, senza impurità, chiamata Pietra filosofale che proiettata sui metalli comuni (piombo, stagno) permetteva di trasmutarli in oro, l’oro dei filosofi non l’ aurum vulgi . Trovare la Pietra filosofale significava, infatti, scoprire l’assoluto, possedere la conoscenza perfetta, la gnosi salvifica.
Le fasi dell’opera alchemica definiscono l’alchimia come un percorso iniziatico concreto, simile ai percorsi rituali dei misteri iniziatici presenti in molte religioni (ricordiamo soltanto i piccoli e grandi misteri eleusini). Mentre la Piccola Opera ha per fine il ritorno dell’anima al suo stato di purezza e ricettività originale, il fine della Grande Opera è l’illuminazione dell’anima da parte dello spirito, chiamato in qualche modo a discendere in essa: il fuoco celeste incendia il cuore e lo purifica. Nell’ermetismo islamico la rubedo equivale all’accesso ai grandi misteri, all’uscita dalla condizione individuale. Lo zolfo rosso designa l’Uomo Universale, l’ Adam qadmon .L’Opera al Rosso, la Suprema Grande Opera (Opera mistica, via dell’Assoluto, via della fenice) doveva dunque portare l’uomo a superare i conflitti in una sintesi superiore, la coincidentia oppositorum , a raggiungere il suo vero Sé, e a ritrovare la sua originaria dignità.
Le parole di un grande alchimista francese, Nicolas Flamel, la cui figura è circonfusa dal segreto che sempre avvolge la vita e l’opera degli iniziati, ci sembra spieghino con grande evidenza il senso di pienezza e di realizzazione spirituale rappresentato dal colore rosso. Nella sua Explication des figures hiéroglyphiques egli scrive:
«Su un campo viola scuro, un uomo rosso porpora sta ai piedi di un leone color rosso lacca, che ha le ali e sembra volerlo portar via. Il campo viola scuro vuole indicare che la pietra ha potuto ottenere, grazie alla sua completa infusione, gli abiti arancione e rossi indossati da San Pietro, al quale erano stati domandati; e che la sua completa e perfetta assimilazione, significata dal colore rosso, le ha permesso di smettere il suo vecchio vestito arancione. Il rosso lacca del leone volante, simile al puro e chiaro scarlatto che ha il seme della rossa melagrana, dimostra che in tutto la Pietra si è realizzata, rettamente e genuinamente. Perché essa è quel leone che divora ogni pura natura metallica, e la trasforma in vera sostanza, in vero e puro oro, più fine di quello delle migliori miniere.
Così trascina l’uomo fuori da questa valle di lacrime, voglio dire che lo libera dal fardello della miseria e dell’infermità, e lo solleva gloriosamente con le sue ali oltre le acque putride di Egitto, – i pensieri comuni dei mortali – facendogli disprezzare la vita e le ricchezze dell’oggi, notte e giorno, facendolo meditare in dio e nei suoi santi, sospirare il più alto dei Cieli e bere alle dolci sorgenti delle Fontane dell’Eterna Speranza ».
Il fatto che l’opera alchemica si concluda con il colore rosso sembra voler significare che alla spiritualizzazione del corpo – simboleggiata dal candeggiamento del nero originale – deve succedere l’incorporazione dello spirito. L’accento verrebbe quindi posto non sul ritorno al cielo, ma sulla manifestazione di quest’ultimo sulla terra (cf. Titus Burckhardt, Alchimia , tr. it . 1986) e sull’unione di queste due polarità in una coincidentia oppositorum .
Ancora una volta le parole di T. Mann ci sembrano una guida preziosa che muovendo con ermetica leggerezza tra i molteplici piani simbolici e metaforici (proprietà assolutamente usuale agli antichi alchimisti, ma lontana dalle abituali modalità percettive ed espressive della nostra epoca moderna) ci fa intuitivamente cogliere l’ontologica congiunzione degli opposti:
Se «anima e spirito sono una volta stati una cosa sola vuol probabilmente dire che esse dovranno una volta divenire una cosa sola.
Lo spirito per sé e in maniera essenziale rappresenta il principio del futuro, il “sarà ” e il “deve essere” mentre la pia religiosità dell’anima unita alla forma si volge al passato e al sacro “fu”.
Dove in questo sia la vita e dove la morte resta controverso, perché le due parti, l’anima strettamente avvinta alla natura e lo spirito che é fuori del mondo, il principio del passato e quello dell’avvenire rivendicano a sé, ciascuno a suo modo, di essere l’acqua della vita e ognuno accusa l’altro di stare a servizio della morte. E nessuno dei due ha torto: infatti la natura senza lo spirito e lo spirito senza la natura possono difficilmente chiamarsi vita. Ma il segreto e forse la nascosta speranza di Dio è nella loro unione, in un vero e proprio immettersi dello spirito nel mondo dell’anima, nel fondersi dei due principi e nella santificazione dell’uno per mezzo dell’altro, per attuare una umanità benedetta con la benedizione dall’alto e con la benedizione dal profondo .» ( Le storie di Giacobbe )
Tornando al rosso colore del fuoco e del sangue, e dunque della vita, vogliamo sottolineare l’ambivalenza simbolica di questo colore. Esiste infatti un rosso notturno, femminile, che ha un potere centripeto di attrazione, l’altro maschile diurno, centrifugo, turbinoso come il sole, che getta luce su tutte le cose con una potenza immensa e irresistibile (A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli ).
Il primo rosso è il colore del fuoco umano e terrestre che brucia nell’athanor degli alchimisti, in cui si operano la digestione, la maturazione, la rigenerazione dell’essere o dell’opera e rappresenta il segreto, il mistero vitale nascosto nel fondo delle tenebre e degli oceani primordiali, nel ventre archetipico in cui morte e vita si trasmutano l’uno nell’altra. E’ infatti il colore dell’anima, della libido, del cuore, e anche il colore iniziatico della conoscenza esoterica acquisita attraverso la morte iniziatica. I misteri di Cibele prevedevano che gli iniziati si rigenerassero alla nuova vita scendendo in una fossa dove ricevevano sul loro corpo il sangue di un toro o di un montone ritualmente sacrificato.
Tale rosso può però divenire pericoloso come l’istinto di potenza non controllato che conduce all’egoismo, alla passione cieca, all’amore infernale: rosso è il mantello dei principi dell’inferno e di Mefistofele.
Ma esiste un rosso, diurno, solare, che associato al bianco e all’oro costituisce il simbolo essenziale della forza vitale e generosa della bellezza, intesa come kalokagathia , modello di perfezione.
Il simbolismo del rosso che riguarda il divino e le sue manifestazioni affonda nelle più antiche tradizioni religiose (René Gilles, Le Symbolisme des couleurs , Paris 1961).
Nell’estremo oriente il rosso colore del cinabro (solfuro rosso di mercurio) è simbolo di immortalità in quanto nel processo di combustione, morendo nel fuoco, produce mercurio e dunque ci parla del mistero della rigenerazione attraverso la morte.
In Persia il fuoco è il soffio divino di Ahura Mazdah.
Presso gli Egiziani un cerchio rosso circondato da due serpenti verdi con ali dalle penne rosse e bianche era il simbolo dell’unità e dell’amore di Dio, la cui potenza non ha né inizio né fine (e si estende dappertutto in forma perfetta di circonferenza), della creazione, della rivelazione della saggezza e bontà divina, e infine dell’atto (il verde) di questa conoscenza.
In India, il fuoco del sacrificio era simbolo del fuoco divino e rosso è il colore di Brahama, il creatore del mondo che nasce nel loto del cuore dell’uomo, immagine della particella dell’anima divina che arde in ogni creatura umana.
In Grecia il colore rosso simbolizzava l’amore rigeneratore. Rosso è il viso del dio p an, il grande Tutto e il fuoco eterno, come lo chiama Orfeo. Rosso è il dio creatore e animatore dell’universo, il grande Eros, il primo dio uscito dal Caos, figura del desiderio e del divenire. Rosso è anche il colore di Dioniso, dio della libertà e dell’estasi.
In lingua ebraica il primo uomo è chiamato Adamo, che vuol dire rosso perché Dio, avendolo creato soffiò nelle sue narici il fuoco dell’amore divino e della Verità Divina. Il rosso e il bianco sono i due colori di YAHVE’, dio d’amore e di saggezza, ma anche dio dal volto terribile che attraverso il fuoco purifica e rigenera le anime e trasforma il mondo creato (cf. Apocalisse VIII, 7-8 e XVIII, 8).
Nella liturgia e nell’arte cristiana tradizionale il rosso era il colore del sangue sacrificale di Cristo e dei martiri, dell’amore fervido e della fiamma pentecostale dello Spirito Santo che rigenera gli uomini attraverso l’amore liberatore della verità. Rosse sono anche le ali dei Serafini (il cui nome Seraph significa pienezza d’amore).
I pittori di icone, come ci ricorda Evgenij Trubeckoj, attraverso il misterioso profondo brillante color porpora del cielo che costituisce uno dei più grandi fascini dello stile iconografico Novgorodiano, sapevano comunicarci il complesso mistero della mistica coincidentia dei due piani dell’esistenza: quello terreno e quello ultraterreno.
Ancora più arduo e complesso il mistero mistico del colore purpureo della S. Sofia, Saggezza Divina assisa in trono sullo sfondo azzurro-cupo del cielo notturno stellato. «Proprio il contatto con le tenebre notturne rende straordinariamente bella questa apparizione del porpora celeste, e proprio in questo contatto sta la spiegazione simbolica di un tale colore. “hai fatto tutto con Sapienza” si canta nel salmo. Ciò significa che la Saggezza è proprio quell’eterno pensiero divino sulla creazione che chiama ogni creatura celeste o terrena dalla tenebra della notte, dal non essere, all’essere.»
Queste parole dello scrittore russo ci fanno profondamente sentire il significato dell’imperioso richiamo del fuoco celeste e ci rimandano ai versi del nostro grande poeta Dante passato dal fuoco terrestre al fuoco celeste.
Dante nella Divina Commedia ha figurato questo passaggio. Egli ha cantato come nel cammino iniziatico che doveva portarlo fuori dal purgatorio e farlo pervenire di fronte alla “Gloria di Colui che tutto muove” aveva dovuto incontrare ancora una volta il fuoco, ma non il fuoco delle passioni cieche infernali, bensì un fuoco purificatore e trasformatore che doveva incenerire gli ultimi residui della sua natura terrestre e renderlo puro e ‘disposto a salir le stelle’.
Simile doveva essere quel fuoco nel quale la dea Demetra aveva gettato il piccolo Demofoonte, per iniziarlo ad una nuova vita, al di là della morte, come veniva celebrato nei riti dei misteri eleusini.. La leggenda narra che la dea, nel suo doloroso peregrinare in cerca della figlia rapitagli da Ade-Plutone, era stata accolta ad Eleusi come ospite, sotto le sembianze di una vecchia nutrice, dal re Celeo e dalla moglie Metanira che le avevano affidato la cura del loro figlio Demofoonte. Demetra, gettando nel fuoco il bambino, voleva trasformarlo da mortale a immortale; tuttavia la madre, entrata all’improvviso nella stanza, gridando spaventata, aveva provocato l’indignazione della dea e interrotto quel rito di iniziazione e di immortalità.
I versi del Purgatorio (XXVII, 10 e sgg.) spiegano con chiare lettere la necessità di questo passaggio attraverso il fuoco e l’umano timore ad affrontare la terribile prova. E’ necessaria tutta l’amorevole sollecitudine del maestro e guida Virgilio che infonde coraggio a Dante, lo sprona e continuamente gli ricorda la meta e l’ogetto ultimo dei suoi desideri.
«“Più non si va, se pria non morde,
anime sante, il foco: intrate in esso,
ed al cantar di là non siate sorde”
Ci disse come noi li fummo presso;
per ch’io divenni tal, quando lo ‘ntesi,
qual è colui che nella fossa è messo.
In su le man commesse mi protesi,
guardando il foco e immaginando forte
umani corpi già veduti accesi.
Volsersi verso me le buone scorte;
e Virgilio mi disse: “Figliuol mio,
qui può esser tormento, ma non morte.
(…)
Pon giù omai, pon giù ogni temenza:
volgiti in qua; vieni ed entra sicuro!”
E io pur fermo e contra coscienza.
Quando mi vide star pur fermo e duro,
turbato un poco disse: “Or vedi, figlio:
tra Beatrice e te è questo muro”.
(…)
Poi dentro al foco innanzi mi si mise,
(…)
Sì com’ fui dentro, in un bogliente vetro
gittatomi sarei per rinfrescarmi,
tant’era ivi lo ‘ncendio sanza metro.»
Solo dopo esser passato per questo fuoco è possibile per Dante compiere l’ultimo tratto del suo cammino, raggiungere la vera meta del suo pellegrinaggio, compiere il compimento del suo destino, il telos .
Qui lo abbandonerà Virgilio e le parole con cui lo affida ad altra guida mi sembrano significative per coloro che si propongono il compito di accompagnare gli altri in un tratto del loro cammino di crescita psicologica e spirituale:
« Come la scala tutta sotto noi
fu corsa, e fummo in su’l grado supremo,
in me ficcò Virgilio li occhi suoi.
E disse “il temporal foco e l’etterno
veduto hai figlio, e se’ venuto in parte
dov’io per me più oltre non discerno.
Tratto t’ho qui con ingegno e con arte;
lo tuo piacere omai prendi per duce:
fuor se dell’erte vie, fuor se’ dell’arte.
(…)
Non aspettar mio dir più, né mio cenno:
libero, dritto, sano è tuo arbitrio,
e fallo fora non fare a suo senno:
per ch’io te sopra te corono e mitrio.”»
(vv.124 e sgg.)
Qui si fermano le possibilità della guida Virgilio che però ha saputo aiutare Dante a passare al di là delle vie più anguste, a raggiungere Sé stesso, nella pienezza delle possibilità dell’uomo creato a simiglianza del Creatore.
Solo dopo aver raggiunto tale pienezza, Dante è in grado di sostenere con lo sguardo un altro color porpora ed altri fuochi ed altre luci, da cui non rimarrà consumato o annichilito, ma che anzi lo avvolgeranno nel loro fulgore facendogli sperimentare una nuova dimensione dell’umano:
«Come subito lampo che discetti
li spiriti visivi, sì che priva
dall’atto l’occhio di più forti obbietti;
così mi circunfuse luce viva;
e lasciommi fasciato di tal velo
del suo fulgor, che nulla mi appariva.
“Sempre l’amor, che queta questo cielo,
accoglie in sé con sì fatta salute,
per far disposto a sua fiamma il candelo”.
Non fur più tosto dentro a me venute
queste parole brievi ch’io compresi
me sormontar di sopr’a mia virtute;
e di novella vista mi raccesi,
tale, che nulla luce è tanto mera,
che li occhi miei non si fosser difesi.
E vidi lume in forma di rivera
fulvido di fulgore, intra due rive
dipinte di mirabil primavera.
Di tal fiamma uscian faville vive,
e d’ogni parte si mettian ne’ fiori
quasi rubin che oro circoscrive.»
( Paradiso XXX, 46 – 66.)
Questi versi di Dante ci porgono in maniera piena e fondante, attraverso immagini vive e creatrici l’ultima fase del processo di trasformazione alchemico, della Grande Opera, cioè l’iniziazione al Grande Mistero (il cui telos è il raggiungimento del Sé) quale che sia il cammino attraverso il quale ad esso si giunga.
Nelle tradizioni artistiche filosofiche religiose più significative, a qualsiasi orizzonte esse appartengano, al culmine del cammino (si chiami Grande Opera, Grande Mistero o altro) l’ epopteia , la rivelazione della Saggezza divina concede l’esperienza del Sé, cioè l’esperienza che comprendendo e realizzando il senso della propria vita, si ritrova anche il senso del Tutto del quale la propria singola vita fa parte. Jung parla di entelechia che si raggiunge a coronamento del processo di individuazione (in cui il singolo riconosce lo stato di non separazione, di non divisione dal Tutto).
L’iniziato, colui che ha ottenuto prima della morte la vera conoscenza, e ha raggiunto così l’individuazione, «… essendo non-diviso , dunque senza le parti o membra che componevano la sua forma terrena (sottomessa alla quantità : contato, pesato, diviso), è liberato dalle condizioni dell’esistenza individuale (…). L’essere non è affatto assorbito quando ottiene la liberazione, anche se così può sembrare dal punto di vista della manifestazione, per la quale la trasformazione appare come una distruzione (…) è invece dilatato oltre ogni limite… poiché ha effettivamente realizzato la pienezza delle sue possibilità.» (R. Guénon , L’Homme et son devenir selon le Vêdânta, 1925 , tr. it. 1992)
L’individuo non è altro che la specifica attuazione di una potenzialità custodita fin dall’inizio in seno all’assoluto, anche se tale attuazione viene descritta in termini di separazione, caduta, distacco, assunzione di forme sempre più stringenti, sottili prima, materiali poi. E reciprocamente il percorso inverso del ritorno all’unità può essere descritto come perdita progressiva delle determinazioni e delle differenze specifiche assunte in precedenza.
Naturalmente si tratta di espressioni metaforiche. Infatti, mai l’individuo potrebbe realmente uscire e staccarsi dal principio per la semplice insuperabile ragione che oltre il principio non c’è niente e che il principio non ammette un oltre . E l’assunzione di forme individuali (in una parola l’individuo) è dunque un evento completamente interno al principio dal quale non poteva separarsi e al quale di conseguenza non poteva ricongiungersi. Così il cosiddetto percorso della liberazione o trasformazione, deve essere inteso simbolicamente come una sorta di riappropriazione dello stato precedente a quello della manifestazione della forma. Lo stato della forma non viene distrutto, o riassorbito perché niente si era mai in realtà allontanato. L’unica possibilità è una radicale intensificazione di ciò che si è, rompere ogni argine frapposto alla completa realizzazione, evitare la fissazione a metà strada. Dunque, il singolo individuo in cui si esprime necessariamente una realizzazione del Tutto (o del Principio) senza che con ciò il Tutto (o il Principio) si allontani da sé e si frantumi, può scoprire, riconoscere, vivere il rapporto interno con il Tutto (o con il Principio), proprio a partire da ciò che egli realizza in sé stesso.
Perché sia la formazione sia la tras-formazione risiedono da sempre in seno al Tutto, e la liberazione o la felicità consiste nella raggiunta consapevolezza (che investe tutto l’essere individuale) che l’individuo è nel tempo stesso necessario e non necessario e che egli deve vivere nell’unione con il Tutto il senso di ciò che ogni individuo è.