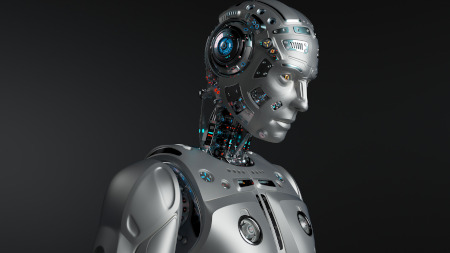Contro il nichilismo vale, dicono, solo la vitalità. Però, la vitalità, come il coraggio per don Abbondio, o c’è o non c’è, nessuno può darsela.
La tesi procede più o meno in questi termini: sopra di noi c’è il Dis-umano, l’Indifferente, eppure “ io ci sono ”, beninteso finché ci sono.

Nella sua versione più drammatica, all’inizio della modernità, l’ io assume la veste del Don Giovanni all’inferno di Baudelaire: nonostante l’inferno, io sono contro. L’uomo in rivolta è un nipotino di questo io, io mondano, senza dio, dopo dio, dissacratore, antitrascendenza.
Una sfida impari, tuttavia. Si sa che è persa in partenza, ma c’è l’ebbrezza della sconfitta.
La sfida dongiovannesca si ripresenta lungo l’arco del mondo moderno in varie forme: se tutto è senza senso, conta allora il senso che «io» do alla mia vita.
In altre parole ci si sposta dalla metafisica all’estetica. Si vede bene la strada che va da Leopardi a Benn, passando per Evola e Jünger, per Beethoven e Mann.
***
Fare appello alla vitalità contro la perdita della vitalità equivale semplicemente a restare passivi e ottusi dentro un circolo vizioso. Molte volte tuttavia questa è stata la via imbocccata dagli uomini, non sufficientemente ammaestrati dalle lezioni del passato. Nel tempo presente, è stato questo il criterio ispiratore praticato in modo chiassoso e radicale dai tedeschi ma in generale dai popoli anglosassoni e da quanti da loro sono diretti e ammaliati.
Parallela a questa soluzione del problema del nichilismo, soluzione che diremo sanguigna e razziale, corre quella cristiana. Qui un solo uomo decide di prendere su di sé il problema, ergendosi a salvatore per intrinseche capacità e essenza. Tanto grave e non comune si presenta il problema che l’umanità attuale non è più giudicata in grado di farvi fronte. Anzi, il problema nasce esattamente dalla decadenza dell’umanità. Di modo che soltanto un uomo speciale, unico, che abbia in sé le caratteristiche dell’uomo antecedente alla crisi, può assumersi il compito di invertire la discesa e portarsi dietro quanti vorranno seguire l’uscita di sicurezza da lui aperta.
Dietro questa proposta si intravede la più antica figura di uomo santo che l’umanità conosca: lo sciamano.
In verità, lo sciamano sta anche dietro la proposta parallela che abbiamo definito sanguigna. Appartiene al quadro sciamanico, infatti, la tecnica della trasvalutazione del corpo e la amplificazione delle sue potenze.
Beninteso, razzismo anglosassone e cristianesimo altro non sono che derivate del modello, derivate di grande spessore e persino molto più antiche del loro stesso apparire storico, eppure di esso hanno perso il punto più profondo e perciò annaspano, annaspano affascinando ma scivolano sul problema.
Circa il punto profondo essenziale dello sciamano diremo, in sintesi, che lo sciamano non ha da risolvere alcun nichilismo, in quanto non sente di operare in un quadro segnato dal senza senso. Al suo livello il problema del senso non esiste ancora. Allo sciamano il mondo sta bene come è. Cioè, a essere precisi, non sta bene, semplicemente è quello che è. L’essere è, e tanto basta. Non c’è spazio per nessuna sfida, nessun disprezzo, nessuna malinconia.
Il problema del senso assume una piega labirintica e senza uscita perché sposta tutto il fine della vita nell’interrogazione rivolta a un dio che sarebbe responsabile del senso.
Ma anche quel dio, se ci fosse, avrebbe lo stesso problema e sarebbe impotente.
Nel profondo dello sciamano c’è invece un’altra percezione del reale, dunque un altro ethos: non c’è la domanda.
Quello che per noi è diventata una domanda, per lo sciamano aveva un’altra consistenza: era un debito.
Dal debito alla domanda. Questo è il percorso della crisi.
L’arcaico sciamano spiega a coloro che lo consultano quale sia il loro debito.
«Siete nati per dare qualcosa, siete qui per restituire qualcosa che avete preso in anticipo. Non avete il problema di risolvere il nulla, il nulla non c’è» – così avrebbe detto, se ci fossero state le condizioni preliminari per formulare una simile domanda che in effetti potrà venire formulata solo dopo la crisi.
Il debito si trasforma in domanda per coloro che non vogliono restituire niente. Per coloro che sono avidi. Avidi perché invasi dal senso della carenza, e invasi da tale sentimento perché qualcosa si è incrinato nel rapporto con il reale.
Il debito si trasforma e distorce, rarefacendosi il rapporto con il reale, in dovere, in sollen, in must, in legge morale. Invece si tratta di cosa molto più terra terra, molto più concreta: niente dovere, oggetto di indagini metafisiche e filosofiche, bensì debito. Ognuno ha il suo, ognuno la sua parte, parte che non è solo sua, ognuno la sua moira, come ancora dicevano i greci.
Ciò che abbiamo preso, tanto dobbiamo restituire. Un bilanciamento, uno scambio, un passaggio. Il resto è una trappola che nasconde la protervia e la cecità. Nessuno sarà in grado di trattenere per sempre ciò che ha avuto. In primo luogo il corpo, il sangue. Poi le cose immateriali.
Imparare a restituire, questo può sembrare terribile solo a coloro che non sanno più guardare di che cosa stiamo trattando. Restituire, fare la propria parte. Parte. Non sta a noi dare a essa un senso diverso e in aggiunta a quello che già ha di per sé. La parte è già la moira. In essa c’è già tutto quello che serve per vivere.