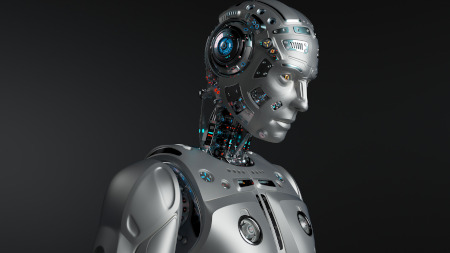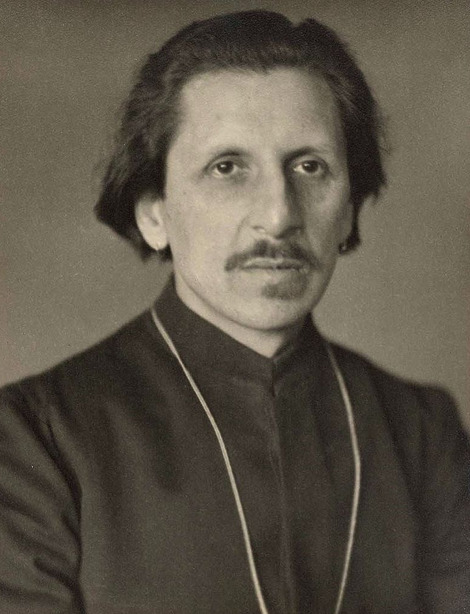Indichiamo alcuni tra i più rilevanti temi della spiritualità
della Sardegna antica trattati dal recente saggio
di Giuseppe Lampis, ‘ Sa bia de sa palla’. La Via Lattea in Sardegna, Roma, Mythos 2003
Nel Museo Archeologico di Cagliari si può osservare un bronzetto che gli archeologi hanno individuato come un modellino di nuraghe a quattro torri.
Frobenius va oltre la banale evidenza e si chiede di quale originale a sua volta esso sia modello. Di che cosa è immagine il nuraghe?
L’esimio africanista mette in relazione quell’immagine con l’immagine paleolitica della terra a quattro colonne che reggono il cielo.

Nessuna forma architettonica, neanche la più piattamente grossolana e acritica, potrebbe prescindere da un concetto profondo del senso dello stare sulla terra.
I nuraghi sono opera di un popolo di guerrieri dell’età del bronzo, padroni di una avanzatissima tecnica architettonica. Le costruzioni megalitiche sono per sempre. Per un uso transitorio c’è la tenda o la capanna di frasche o la casa di fango impastato con paglia. L’artefice del nuraghe si distingue in quanto si pone un problema metafisico: le sue opere devono durare per sempre. Devono durare per sempre perchè ciò che esse rappresentano è l’eterno. L’ordine eterno.
La maestà ancora attuale della torre nuragica «che attraversa i millenni» testimonia del suo carattere sacrale; il suo enigma, su cui inciampiamo, raddoppia lo sgomento.
Il materialismo riduttivo della scienza contemporanea la ha sbrigativamente classificata come un fortilizio più o meno complesso. Che una brocca sia una brocca, alla fine non è una vera spiegazione. Non appena prendiamo atto della assoluta ovvietà che una fortezza del 1500 a. C. non è una torre conica spagnola del 1500 d. C., ci accorgiamo che non avevamo messo i piedi sul terreno fermo bensì su un piano inclinato assai sdrucciolevole.
Il nuraghe, soprattutto il nuraghe, è una imago mundi. La strada da percorrere è quella indicata da Frobenius: cercare la visione del mondo sottesa.
Non abbiamo molte strade a disposizione. Una potremmo chiamarla esterna, e è quella dell’etnologo (le cui conoscenze di altre etnie e culture aiuta a integrare i vuoti). L’altra è interna, intrinseca del nuraghe.
*
La tecnica in quell’epoca (e non solo) non era un’arte desacralizzata e non aveva soltanto una dimensione materiale. Del resto la tecnica edilizia ha per natura il compito di trattare precisamente con la multidimensionalità.
Il monaco cistercense che tira su le possenti nervature della cattedrale gotica sta pensando a un sapere e a un compito. La cupola del Pantheon romano esprime la sintesi di una ampia dottrina e la traduce in un atto denso di influenze.
Ora, studiando la tecnica del nuraghe si deve arrivare, per questa via intrinseca, alla visione del mondo sottesa e incorporata in esso. L’architetto nuragico non ha edificato una semplice fortezza perché non è il Sangallo, però lo stesso Sangallo non faceva semplici fortezze.
Per fare un nuraghe occorreva mobilitare e organizzare il lavoro di molti operai, a partire dalla raccolta e dallo squadro dei grandi blocchi di pietra necessari per proseguire con il loro trasporto e concludere con la messa in opera. Tutto ciò non ha niente a che vedere con una società individualistica e dispersiva, né con piccole comunità autosufficienti. Tutto ciò importa un ordine sociale complesso e la emersione di una classe aristocratica capace di estendersi su vasti territori e su masse numerose di loro abitanti. Se si tiene conto del fatto che la densità degli abitanti per chilometro quadrato doveva essere assai bassa, più bassa di quella già scarsa in epoca storica, si deve ammettere che perfino una singola torre nuragica di medie dimensioni implica che una élite dovesse esercitare il suo dominio su un comprensorio sufficientemente esteso per fornire la leva operaia necessaria. Molte torri inoltre sono l’una in vista dell’altra, il loro rapporto disegna ampie contee. Fra i monumenti che conosciamo, ce ne sono alcuni che impongono un discorso ulteriore. Il nuraghe Losa , il Sant’Antine , lo Oes , e quelli rifasciati da bastioni turriti a quadrilatero o a triangolo, di Barumini, di Villanovaforru, il Palmavera di Alghero, sono costruzioni di tale imponenza da potere essere giustificate soltanto dalla esistenza di maturi principati regionali.
Gli archeologi fanno notare la originalità della tholos nuragica rispetto a quella micenea. La disposizione delle file concentriche di pietre nelle tombe a tholos greche affronta e risolve un problema diverso, inverso addirittura, di quello affrontato e risolto dai nuraghi. Lì si deve reggere una collinetta di riporto e la spinta del peso sovrastante la cupola che si scarica sui muri laterali è compensata dal terrapieno che circonda la camera e forma il tumulo. Il nuraghe invece è a cielo aperto, non è abbracciato da alcun terrapieno. Il peso che grava dalle pietre più alte è tutto sostenuto dallo spessore delle sue muraglie: più alta è la torre, più spesso deve essere il muro; più largo si vuole il cortile interno, più alta deve essere la torre e di conseguenza più larga la sua base. Il nuraghe ripete in sé a cielo aperto e a tutto tondo il tema del tumulo che si èleva.
Il problema che eminentemente il nuraghe adotta come suo e che risolve è di «reggere l’alto».
La tomba falsamente sotterranea di Micene viene costruita a partire dal cerchio di pietre del suo perimetro, sulla prima fila si dispone a arte una seconda fila più stretta aggettante verso il centro, sicché il muro crescendo assume un andamento che converge sempre più verso la ultima pietra, quella che chiuderà definitivamente la cupola. Questa pietra non è ancora però la chiave di volta in cui si risolve la vera cupola a cielo aperto, cioè quel mantello di pietre che si appoggia tutto su un centro che sta collocato in alto. La cupola è retta da un perno che sta più in alto: strabiliante rovesciamento delle leggi apparenti della natura, sublime rarefazione della materia, perfetta dimostrazione di un assunto metafisico, che il mondo non sia retto dal basso bensì dall’alto. L’ultima pietra al centro della falsa cupola della tomba di Micene non è la chiave di volta. Ma i Micenei non volevano fare ciò che viene loro erroneamente attribuito, tanto che la loro opera effettiva viene ora indicata come un falso. Essi conoscono le problematiche dello scarico laterale del peso che insiste su un’architrave, la porta delle leonesse rampanti sulla colonna le ha risolte egregiamente. Il fatto si è che, con le tombe a tumulo rivestite nella concavità interna da una controcupola, essi volevano proprio costruire una tomba.
Nei nuraghi si propone una altra intuizione dei rapporti spaziali e degli elementi materiali. Essi sono disposti per una altra funzione.
Ciò che regge l’alto, in essi, non è una collinetta di terra sotto la cui concavità sia stata disposta una cupola di pietre concentriche. In altri termini, essi non rappresentano il mondo di sotto. Rappresentano, invece, il mondo di mezzo. Solidamente elevato al cielo dalla terra, un monte. Il nuraghe è un monte.
Non è il cielo superiore, non è il cavo sotterraneo infero, è il medium, elevato verso l’alto e saldamente piantato in basso. Il nuraghe trascina con sé tutta la densa simbologia della montagna del mondo.
*
Genti che precedettero i Nuragici avevano eretto l’altare di Monte d’Accoddi, un terrapieno elevato a cui si accede mediante una rampa, un altare ziqqurat. La Sardegna in quel tempo rientra nella ecumene che gravita sulla mezzaluna mesopotamica. I dinamici e avventurosi Nuragici hanno puntato la loro prua su rotte ben note.
Il nuraghe ripensa e reinterpreta lo stesso tema, in modo più dinamico. Tanto è statica e pesante la ziqqurat poggiata sulla piana al cui sbocco due millenni dopo sorse la romana Turris quanto leggera e elastica è la torre nuragica. Nella torre nuragica c’è il senso della tensione, trattenuta, retta, dominata; eppure il peso e lo sforzo si devono vedere. Già i pesanti conci non sono dei parallelepipedi grevi e fissi, sono dei conoidi rettangolari che hanno bombata la sola faccia a vista.
Il nuraghe vuole rendere esplicito il programma etico del suo uomo: «reggere i pesi», «io posso».
In sardo ancora oggi per dire «reggi» si dice « podèra »: pesa, tira su, reggi un peso. Quando si vuole indicare che uno è forte, si dice che pòdidi , che può, e si tenga presente che potere significa molto concretamente essere forti fisicamente tanto da essere in grado di sollevare pesi enormi.
Il nuraghe è, e con chiarezza così esplicita che quasi non si vede, l’emblema del potere, nel senso suddetto.
L’uomo che si era posto il fine di reggere il cielo piantando i piedi bene in terra ha fatto i nuraghi.
*
Questo uomo lo abbiamo incontrato e lo incontreremo ancora nella storia. Sotto altri cieli e in altri tempi riconosciamo i documenti di una tradizione sorretta dallo stesso dèmone. In Sardegna si presentò, allora, un ethos eroico. Si presentò un artefice che intuiva se stesso come mediatore tra cielo e terra.
La mediazione del grande mediatore che completa la creazione ha subìto spesso il destino di essere fraintesa. L’accento può venire fatto cadere o troppo di là o troppo di qua. Certo, ciò dipende dalle forme storicamente concrete con cui la mediazione si fa avanti e che possono indurre l’interprete a collocare la sintesi in un punto sbilanciato in alto o in basso sulla verticale.
Il mediatore – questo è il punto qualificante – mette le mani nella materia, non sfugge alla dura indigesta esistenza dei problemi mondani. Quali siano questi problemi, ovvero quale ne sia la sua percezione e il suo deciframento, si capisce controluce dalla forma con la quale egli si alza in piedi a risolverli.
Il costruttore di torri sempiterne innanzitutto opera con la pietra, egli coltiva una metafisica della pietra. Infine costruisce una montagna che contiene una cavità, egli pratica una metafisica della caverna o, meglio, della uscita dalla caverna.
In termini generali, la mediazione è l’arte di stabilire una comunicazione e un passaggio. Nel nostro caso, il passaggio avviene tra il basso (o interno) e l’alto (o esterno). Lo specifico della intuizione nuragica consiste nella lettura della pietra. Il nuragico si colloca all’interno del problema dominante nella epoca dei primordi dell’uomo e lo forza in una direzione specifica. Per lui la pietra non è ferma, non è più il sotterraneo che chiude e schiaccia; essa può essere spostata e riformulata e dominata.
Per l’uomo sardo dei primordi, nelle pietre sono incorporati i morti e gli antenati; gli antenati sono pietre, la pietra è il mondo della morte. Si tratta di un mondo potente, immodificabile, eterno, prioritario.
Le aristocrazie nuragiche dimostrano di avere svolto una meditazione diversa, partendo dallo stesso punto.
Esse dimostrano di avere una altra visione del destino. Questo popolo enigmatico fu attratto da una terra di pietre, nella quale si adoravano le pietre. Nessun invasore si muove a casaccio. Nessuno va a oriente o a occidente indifferentemente. Nessuno va, piuttosto che non, piuttosto che stare fermo, in modo gratuito. Certe scelte rispondono a considerazioni profonde. Non hanno il carattere della quotidianità. Non si può evitare di riconoscere nelle cosiddette migrazioni, specie se impegnano a ondate intere stirpi e le arrischiano in destini travolgenti, un atto di alto significato etico e una ispirazione che riguarda il senso dello stare al mondo.
I guerrieri nuragici non erano commercianti materialisti, non erano i Fenici, che in seguito prevalsero su di loro, sulla onda lunga del montare delle forze economicistiche. Essi erano forgiati in un’altra disciplina, in quella della guerra. Il combattente armato segue un dio che insegna l’arte della vita attraverso l’arte della morte.
Il nuragico, forse già chiamato Sharden, è l’uomo che sa «fare la morte».
Un identico circuito lega e rende coerenti la sua visione del mondo – e la sua metafisica della morte – con l’impegno insistente nel costruire le settemiladuecento torri finora documentate e le altre, che non troveremo mai in quanto saccheggiate nei secoli successivi per poggiare altri edifici secondo la regola ben nota che fece sciogliere in calcina i monumenti della antica Roma.
Regola di ignoranza, e in più di fastidio e odio, ottuso e gretto, alimentato da una falda sotterranea mai esaurita.
*
La statuetta (dal santuario nuragico di Abini, presso Teti) del guerriero doppio – due braccia per ogni spalla e due scudi rotondi uno a destra e l’altro a sinistra, due coppie di occhi per ogni sopracciglio – esprime un ideale.
Uno Janus cubista. Conosco numerosissime maschere africane bifronti, e fra le più strane e intenzionalmente spaventose quelle dei popoli che gravitano sul golfo di Guinea, ma questo è un bifronte scolpito in modo che la sua forza sia tutta presente sul piano frontale. Il piano frontale è a due dimensioni e per sviluppare il solido a tre dimensioni sul piano bisogna diventare cubisti e portare davanti ciò che sta di fianco.
Il piano del davanti è pertanto quello in cui si proclama la idea della contemporaneità e dalla compresenza. Esso è il piano in cui tutto sta subito e immediatamente insieme, prescindendo da ciò che si vede di solito, un piano altamente metafisico, non fisico, nel quale si visualizza il pensiero, nel quale si fa vedere ciò che solo può essere pensato.
Riportate sullo stesso piano (cioè, pensate) abbiamo le due facce, i due versi, destra-sinistra, notte-giorno, passato-futuro, prima-poi, dritto-rovescio. La sintesi è raccolta nella terza prospettiva atemporale che qui è proclamata con l’avvicinamento da scuola cubista, secondo il quale le facce sfalsate e laterali si dispongono entro le due dimensioni dell’eterno presente, nel qui.
*
Sorprendenti anomalie fisiche fino al limite del mostruoso, connesse con un carattere aberrante, ricorrono nella morfologia degli eroi greci. Così nello studio di Angelo Brelich.
D’altronde, dalla angolazione morfologica degli uomini, l’inaudito appare fascinans ma anche tremendum.
*
Il bronzetto non raffigura dei gemelli perché in esso le duplicità si raccolgono programmaticamente in un solo torso puntato su due sole gambe. Inoltre il terribile ha una sola testa e, sebbene monstruoso e marziano, un solo viso.
Dallo stesso giacimento in cui è stato ritrovato proviene un altro bronzetto con due armati quasi affiancati che il professor Lilliu intitola I commilitoni . Essi potrebbero venire interpretati come due guerrieri gemelli – non è necessario che Castore e Polluce per essere gemelli siano l’uno una replica esatta dell’altro -; purtroppo non conosciamo nessuna tradizione sarda che ci offra una traccia per rompere il buio sulla religione retrostante.
Il potere dei gemelli è noto, essi sono sempre stati considerati sacri, sia vitali sia pericolosi. Georges Dumézil ha scritto un saggio fondamentale sull’argomento, che sarebbe utile tenere presente.
A Monastir quando un bue (o un cavallo, o un maiale) ha il mal di pancia viene chiamato un gemello o una genitrice di gemelli, i quali passano il piede (più raramente la mano) sulla pancia dell’animale sofferente, che guarisce.
*
Nel santuario di Abini, la venerazione del doppio ci si presenta dunque con due documenti notevoli.
Il potente dai due scudi è inequivocabilmente doppio, di una dualità che è sintetizzata nella sua corporeità magica.
Egli è un guerriero, multibraccia e multicombattivo, multiocchiuto e multivedente. Avendo moltiplicato la sua capacità di combattimento e di morte, egli tiene insieme i molti versanti della vita e del destino.
I suoi poteri non appartengono a un’anima evanescente e sono propri di una corporeità trasformata e arricchita. Egli non è un esangue sacerdote, è un soldato temuto dai nemici. Chi voglia essere temuto deve diventare come lui.
Il dèmone della statuetta non si nasconde in un mondo di spettri, egli vive piantato sulla terra.
Tutte le figure multiformi partecipano di molti mondi. Nel suo caso, tuttavia, la molteplicità non riguarda nature diverse, come accade nella combinazione di uomo e animale o di molti animali, come accade a Proteo o a Dioniso. Piuttosto si tratta di una molteplicità che resta nell’ambito dell’uomo e in particolare dello stesso uomo.
Ora, ciò che ci dice lo scultore (e la sua dottrina) è che lo stesso uomo non è uno solo, e che in lui si possono suscitare poteri atrofizzati e latenti e fare emergere altri uomini impliciti.
Non bisogna perdere di vista il punto qualificante della dichiarazione dello scultore: tutti i poteri suscitati, evocati, attualizzati, devono venire integrati e mediati, affinché si abbia un risultato positivo e efficace. I poteri non devono esplodere e divaricarsi, un unico petto e una unica testa li devono tenere insieme.
Colui il quale riesce a tanto sta a cavallo dei mondi e degli orizzonti, guarda e vede contemporaneamente da tutti i lati, regge contemporaneamente l’assalto da ogni fianco, fermo, impavido e terribile. Il bronzetto doppio esprime l’ideale aristocratico del «mediatore» guerriero e di certo egli è il guardiano della porta del passaggio metafisico.
*
Arrivava a tale segno l’iniziato delle società segrete di guerrieri sardo-nuragiche. Così ci viene ermeticamente raccontato che diveniva capace di affacciarsi sull’invisibile e che si trasformava in un dèmone dell’eterno presente.
*
Petto, thymós; testa, psyché – se accettiamo i deciframenti filologici di Richard Broxton Onians. Il guerriero conterrebbe così una metafisica del rapporto tra i centri mistici del corpo eroico.
*
Garbini segnala una figura umana «di natura divina» munita di quattro ali, presente in un sigillo filisteo, attinente alla simbologia del re.
*
Quattro occhi ha Fanete, nato dall’uovo primordiale degli Orfici.